Questa sezione riporta i miei interventi pubblicati sulla rivista Hystrio, partendo dal numero più recente (cliccare sulle immagini per ingrandirle).
Incanto e disincanto, nel Don Giovanni di Garella e Lucenti
DON GIOVANNI, di Molière. Regia Nanni Garella. Coreografia Michela Lucenti. Con Michela Lucenti, Maurizio Camilli e con Luca Bandiera, Enrico Caracciolo, Barbara Esposito, Luca Formica, Francesco Gabrielli, Pamela Giannasi, Filippo Montorsi, Mirco Nanni, Tiziano Renda, Roberto Risi, Giulia Sevim Pellacani. Luci Luca Diani. Costumi e trucco Elena Dal Pozzo. Prod. Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con Associazione Arte e Salute (BOLOGNA).
Nel Don Giovanni, nuovo esito del lungo percorso creativo di Nanni Garella con le attrici e gli attori di Arte e Salute, il testo di Molière si fa materia corale, viva, incarnata da presenze fragili che abitano la scena con facce imbiancate e gote rosse: Compagnia di maschere esuberanti e fragili, quasi burattinesche, che recitano a chiare lettere i sentimenti umani nella loro schiettezza. Ogni emozione si mostra, si impone: nulla è alluso, tutto è esposto. La coreografa Michela Lucenti, scegliendo qui di non danzare e di non far danzare, lascia che siano i corpi a portare il peso dell’azione senza mediazione coreografica, incastonati in una partitura ritmica di contrapposizioni. La lingua, aulica e abbondante, struttura un tessuto verbale che si sovrappone e si oppone ai gesti, mentre il fondale cambia colore come espressione degli stati interni, contraltare visivo all’intensità emotiva, quasi un termometro affettivo della scena. L’universo che emerge è commovente e feroce, mosso da duelli, ammazzamenti, fughe e ritorni: non c’è redenzione né condanna, solo la reiterazione di un agire umano privo di reticenze. Le relazioni sono nette, costruite per contrasti: servo e padrone, maschile e femminile, potere e subalternità. In questo contesto spicca il lavoro raffinato e misurato di Maurizio Camilli, uno Sganarello dalle controscene comiche millimetriche, quasi un metronomo interno che scandisce e incrina la gravità del tutto. In chiusura, l’apparizione dell’uomo delle pulizie interrompe bruscamente la rappresentazione: gesto di straniamento, ma anche gesto politico. Come nel corto Che cosa sono le nuvole? di Pasolini – dove i pupi, smessi i ruoli, osservano il cielo e pronunciano la domanda irriducibile sul senso dell’essere – anche qui ciò che resta è un disincanto quieto: che non spiega, che lascia sospeso.
Michele
Pascarella
Pedinando Elsa Morante con Michele Di Giacomo
DODICI
STANZE PER ELSA MORANTE, di Tatjana Motta. Regia Michele Di Giacomo. Con Michele
Di Giacomo, Tamara Balducci. Progetto sonoro Federica Furlani. Progetto
video Vladimir Bertozzi. Progetto luci Luca Telleschi.
Prod. Alchemico tre (CESENA).
«Pedinare il
reale» scriveva Cesare Zavattini, teorizzando una prossimità radicale tra
cinema e vita. Dodici stanze per Elsa Morante sembra far propria questa
tensione, ma con un doppio fondo: l’uso del video in diretta non solo “pedina”
la realtà scenica, la certifica, la amplifica, ma al contempo ne destabilizza
la percezione, moltiplicando i livelli di lettura e introducendo uno scarto tra
ciò che vediamo e ciò che crediamo di vedere. La struttura drammaturgica segue
un tracciato biografico preciso: le stanze abitate da Morante a Roma tra il
1931 e il 1947. Ma più che ricostruzione, si tratta di un attraversamento
poetico e allucinato degli spazi che hanno ospitato la nascita dello scrittore
Morante (e non "scrittrice", come la stessa esigeva). Le stanze non
sono solo luoghi: sono zone della mente e del desiderio, territori
dell’instabilità e della continua metamorfosi. A guidarci è una coppia – Attore
e Attrice – che incarna e accompagna Morante giovane, restituendo le sue
incertezze, ambizioni e pulsioni. Il copione si struttura come una drammaturgia
del movimento e della sosta, tra cartoline lette al microfono, immagini
proiettate e frammenti di dialogo realistico, a tratti poetico e visionario,
dove la parola non solo descrive, ma evoca. Il regista assume anche un ruolo
performativo: manovra dispositivi tecnologici a vista, svela i trucchi e rende percepibile
il meccanismo teatrale. Un’eco del “teatro della mente” e della performatività
delle immagini che richiama Carlo Ludovico Bragaglia, citato nello spettacolo
come ospite che temporaneamente nasconde Morante e Moravia in fuga dai tedeschi:
vien da pensare al celebre Fotodinamismo dei fratelli Bragaglia, con cui questa
regia pare condividere l’idea che un’immagine non fissi il reale, ma lo
moltiplichi, lo renda opaco e interrogabile. Il risultato è un teatro che non
cerca la biografia ma un’ombra: quella di una donna che scriveva per vivere, e
per vivere scriveva. E che, come i suoi personaggi, abitava stanze reali e
mentali, sospese tra isole, Storia e sogno.
Michele Pascarella
Lodo
Guenzi, fantasma tra le rocce
TOCCANDO IL VUOTO, di David
Greig. Regia Silvio Peroni. Con Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Giovanni
Anzaldo, Matteo Gatta. Scene Eleonora De Leo. Disegno luci Gianni
Bertoli. Musiche originali Oliviero Forni. Prod. Pierfrancesco Pisani e
Isabella Borettini per Infinito, Argot Produzioni e Accademia Perduta
Romagna Teatri. In collaborazione con AMAT.
Toccando il vuoto porta in scena un
racconto di montagna che si fa vertigine esistenziale. Lodo Guenzi si muove
come un’ombra tra le rocce, un fantasma della memoria che emerge e scompare nel
nero scenico, evocando con la voce e il corpo il dramma di un uomo sospeso tra la
vita e la morte. La drammaturgia e la regia giocano su un montaggio
paratattico: brevi scene che si accendono e si spengono come lampi nel buio, frammenti
narrativi che si connettono nella mente dello spettatore più che attraverso una
mera consequenzialità logica. Le quattro Figure affiorano dall’oscurità con
improvvisi bagliori di luce, si intuiscono, si collegano tra loro in un gioco
di percezioni frammentarie. I reiterati slittamenti temporali scandiscono la
narrazione: passato e presente si intrecciano, mentre il protagonista e gli
altri personaggi rivivono l’incubo nella lotta contro il destino. Il dialogo
tra le Figure è veemente e asciutto, fatto di battute brevi e rapide che
imprimono ritmo all’andamento complessivo, alternando tensione e respiro. In
alcuni momenti, narrazione e interpretazione convivono sulla scena, creando un
effetto di doppia realtà: la voce racconta, il corpo agisce, la mente dello
spettatore completa il quadro. La scrittura musicale alterna brani noti (si
inizia con Love Will Tear Us Apart dei Joy Division) a un battito
costante di suoni cupi e ritmici che ricordano il respiro affannoso di chi
lotta per la sopravvivenza, il rumore sordo della montagna, la paura che pulsa
nelle tempie. L’atmosfera sonora amplifica il senso di isolamento e pericolo,
trasformando la scena in un abisso senza appigli. La riflessione su vita e
morte si fa diretta, quasi brutale: non c’è spazio per sfumature o per un
pensiero mediato. Toccando il vuoto non è solo la storia di una scalata
dagli esiti drammatici, ma il ritratto di un’anima sospesa, di un uomo che
cerca un senso nell’abisso.
Michele Pascarella
Recensione di Panchatantra del Grande Teatro di Lido Adriano, p. 68
Grande
Teatro di Lido Adriano, avventura dei molti
PANCHATANTRA O LE MIRABOLANTI AVVENTURE DI KALILA E DIMNA, regia Luigi Dadina. Drammaturgia Tahar Lamri. In scena il Coro del Grande Teatro di Lido Adriano. Coproduzione CISIM/Lato Oscuro della Costa e Ravenna Festival (RAVENNA).
È uno di quei casi in cui, a indicare per intero i crediti del progetto, si sarebbe esaurito lo spazio a disposizione. Non a caso il libretto di sala riporta unicamente il lunghissimo elenco di nomi di chi, in quella vivace e complessa periferia romagnola, ha dato vita a quest’opera utopica. Giunto alla seconda edizione, il Grande Teatro di Lido Adriano è figlio di alcuni decenni di lavoro con e per i molti, come si usa dire nel Teatro delle Albe, che Dadina ha co-fondato e di cui in questa avventura etica ed estetica (sarebbe riduttivo chiamarlo spettacolo) si ritrova in primis il riferirsi a un testo letterario da usare come trampolino, per dirla à la Grotowski, per muoversi verso un altrove. La raccolta di favole del III secolo Panchatantra, strutturata in un racconto-cornice dentro cui si innestano settanta storie ideate per trasmettere precetti morali, che dall’India del Brahmanesimo giunge alla Francia di La Fontaine, si incarna in una messinscena che partendo da un prologo in spiaggia, in cui due officianti danno forma sonora al largo che giunge dal mare, attraverso alcune tappe narrative fa muovere, concretamente e metaforicamente, il pubblico verso e dentro una ridda di facce, età, etnie, lingue, proteiformi abilità, a renderlo (in)direttamente parte di un Coro in cui sperimentare la vertigine del disorientamento. Parallelamente, sono molti i linguaggi che concorrono a creare questo teatro totale: un testo messo-in-vita con sapienza compositiva in un sistema di continui botta e risposta e ritmiche reiterazioni, una componente musicale significante, con brani originali eseguiti dal vivo tra rap e suoni d’Oriente, una scenografia che si innesta su quella del 2023, a dare forma spaziale a questa arte che fa del tempo una condizione e un alleato. Infine, a proposito del tempo: vi è un esplicito posizionamento testimoniale, nel voler pervicacemente raccontare queste storie -e in questo modo- in un mondo che va da tutt’altra parte. Chapeau.
Michele
Pascarella
Eclissi, habitat
adolescente di Balletto Civile
ECLISSI, coreografia
e regia Michela Lucenti. In scena Fabio Bergaglio, Leonardo Castellani,
Giovanni Fasser, Confident Frank, Michele Hu, Thybaud Monterisi, Carla
Vukmirovic. Prod. Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Balletto
Civile, Oriente Occidente.
In principio fu The
Weather Project: era il 2003, Olafur Eliasson fece installare un enorme sole
nella Turbine Hall della Tate Modern, a Londra, monumentale spazio
vuoto che si popolava di luce. Nello stesso anno Michela Lucenti fondava Balletto Civile, progetto artistico nomade di danzatori-attori
alla ricerca di un linguaggio scenico totale. Oltre vent’anni sono passati e
tracce di quel principio affiorano nel recente Eclissi, creato con e per
sette giovanissimi performer, «piccoli pieni in mezzo a un grande vuoto» si
potrebbe dire con Beckett: incarnano una frenesia cinetica e verbale che riceve
e rilancia, dalla vivissima eredità di Lucenti e compagni, il lirismo
muscolare, struggimenti e slanci, febbrili desolazioni ed energiche visioni. Il
sole di Eliasson qui si manifesta e subito si nega: si permane linguisticamente
in un limine, tra canzoni e monologhi, abiti laminati e luci barocche,
coreografie e scene teatrali. Eclissi dà corpo a un habitat, dunque a un
sistema che si costituisce di interrelazioni significanti, su almeno tre
livelli. Verbale: il testo è costruito mediante interviste agli interpreti,
secondo una metodologia resa celebre da Pina Bausch, che Lucenti ha incontrato
attraverso suoi danzatori. Fili tra passato, presente e futuro: nutrimenti che
si tramandano. Adolescente è, nell’etimo, «persona che si sta nutrendo». Coreografico:
i corpi biologici, ma anche luminosi, sonori e materici sono in continuo,
forsennato intreccio. Ognuno, in scena, è anche l’energia dell’altro. Produttivo:
Lucenti è artista associata ERT. Alcuni interpreti provengono da un percorso di
formazione da lei guidato nell’ambito delle attività di quel Teatro Nazionale.
Il testo dello spettacolo è stato pubblicato in una collana realizzata insieme
a ERT. Vale specificarlo per ricordare che le opere, al di là di ogni retorica
romantica, nascono e crescono se inserite in un habitat che lo permette.
Michele Pascarella
Le Troiane
del Lemming, geometria della tragedia
ATTORNO A
TROIA_TROIANE, drammaturgia musica e regia Massimo Munaro. Con Diana Ferrantini
e gli allievi del Corso di Alta Formazione I CINQUE SENSI DELL’ATTORE 2023/2024
Veronica Di Bussolo, Giovanni Cataldi, Marta Plescia, Maddalena Dal Maso,
Simone Spes, Francesca Marzotto, Marina Aspidistria, Carlotta Zampieri. Prod.
Teatro del Lemming (ROVIGO).
La nuova creazione corale del Teatro del
Lemming rilancia con cristallina chiarezza tre questioni cruciali della (loro)
arte della scena. Prima questione: la composizione. Una struttura limpidamente
geometrica, prima rotante e poi pulsante, rapprende e amplifica la tragedia che
questa creazione con veemenza incarna, come una giostra paradossalmente
luttuosa in cui ci trova avvinti. Dà luogo a una sorta di ferale minuetto, la
seconda parte del ciclo attraverso cui Massimo Munaro, intrecciando l'Iliade, le Troiane e l'Eneide, indaga
il tema della distruzione di una civiltà, dello smarrimento e dell'esilio, con
la sapienza compositiva e maieutica che gli è propria. I tragici, espliciti
rimandi all’oggi sono incapsulati in un funesto caleidoscopio a cui un manipolo
di dedite, giovani persone -dunque, etimologicamente, maschere- dà corpo e
voce, pathos e plausibilità. Seconda
questione: la durata. Procede spesso per cicli pluriennali, la ricerca di
questo mutevole ensemble. Forzando, attraverso la concretezza del fare,
l’ontologica caducità dell’arte della scena e, al contempo, intrecciando esplicitamente
l’arcaico passato al più vivo presente (la creazione termina con un frammento
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo), Troiane offre più
d’uno spunto di elaborazione sul possibile rapporto proattivo col proprio
tempo. Terza questione: la centralità della relazione. L’interpellazione diretta
dei sensi dell’attore e dello spettatore, si sa, è da sempre il fuoco del
lavoro del Teatro del Lemming. Il congegno drammatico, dunque etimologicamente
connesso all’azione, a cui Troiane dà luogo pone al centro, ancora una
volta, il tatto e l’olfatto, l’udito e la cinesi, a fare di tutti e di ciascuno
un organismo in azione, prima e più che un mero intelletto chiamato a ricevere
un discorso. Infine: abbiamo usato in queste poche righe il termine «questione»
non come sinonimo di «fatto», ma di «domanda». È teatro che si e ci interroga,
questo. E sa il cielo quanto ce ne sia bisogno.
Michele Pascarella
Voodoo e il teatro trasformativo di masque
VOODOO, con Eleonora Sedioli. Ideazione Lorenzo Bazzocchi. Prod. Masque teatro (FORLÌ).
In denso dialogo omoritmico con
un battente tappeto sonoro, il corpo-teatro di Eleonora Sedioli si offre allo
sguardo nella severa nudità di un tardo pomeriggio estivo in un chiostro di un
antico monastero: luogo perfetto per questa creazione che convoca, senza
letterarietà, la possibilità femminile di farsi sacra, dunque radicalmente altra rispetto a ciò che comunemente
è umano. Tutto è affidato alla malia performativa dell’interprete, sempre in
bilico tra ostensione e nascondimento. Voodoo ha una struttura elementare
(andare da un punto A a un punto B attraverso una serie precisissima e
selvaggia di «cadute verso l’alto», si potrebbe dire con la più celebrata delle
mistiche medioevali, Ildegarda di Bingen), che la sapienza alchemica maturata
da Masque in decenni di lavoro rigorosissimo e appartato rende misteriosa e
ammaliante. Affiorano la Supermarionetta di Craig e la Biomeccanica di
Mejerchol'd o, per affacciarsi nell’ambito delle arti visive -giacché travalica
ogni steccato anche linguistico, questo Voodoo- i corpi lancinanti di Egon
Schiele e quelli ferocemente introversi di Berlinde De Bruyckere, nel suo
muovere lineare da un pesante sgabello a un albero rinsecchito. Vi è così tanta
vita, in così pochi metri. Soprattutto: vi è così tanto mistero. Davanti ai
nostri occhi il corpo-in-azione sembra letteralmente cambiare
consistenza, da carnale a legnosa. Fulcro primario pare essere la respirazione,
da cui origina l’alternanza di tensione e distensione che informa di sé
l’intera performance. A un’organica progressione vocalica di espirazioni
sonore, lamenti, grugniti e risate sguaiate corrisponde un’energica sequenza di
posture stilizzate e bruschi spostamenti nello spazio: «scena-crogiolo in cui
si rifanno i corpi» si potrebbe dire con Artaud «per calpestio di ossa, membra
e sillabe». Quello che è dato a vedere, in ciò che sembra riduttivo, o comunque
improprio, definire spettacolo, è un continuum di 30
minuti di trasformazioni energetiche e modificazioni dello stato di
coscienza e del corpo che l’azione stessa produce sulla
performer. L’anti-grazioso Voodoo incarna un’idea e una
prassi di arte performativa come esperienza, lontanissima da ogni intento
narrativo, che il pubblico può ricevere per via cinestetica. Masque revoca la
figura dello spettatore riformulandone il ruolo in termini di testimonianza:
non opera d’arte, dunque, ma opera dell’arte. Indimenticabile.
Michele Pascarella
---
Recensione di Quijote! di Teatro Nucleo, p. 68.
Quijote! di Teatro
Nucleo, esercizio di rivoluzione
QUIJOTE!, regia Horacio
e Natasha Czertok. In scena Lisa Bonini, Francesca Caselli, Horacio
Czertok, Stefano Del Biondo, Martina Mastroviti, Giovanni Simiele. Voce
narrante Renato Carpentieri. Scenografia Laboratorio Scenografia
Pesaro di Lidia Trecento, Remi Boinot. Scene e costumi Remi Boinot. Sartoria Maria Ziosi, attori e attrici del Teatro Nucleo. Prod. Teatro
Nucleo (FERRARA).
I proteiformi
attraversamenti compiuti dal battagliero gruppo di base alla periferia di
Ferrara -che ha fatto dell’abitare, poeticamente e politicamente, le molte
periferie geografiche e sociali del nostro mondo il punctum della propria
azione- del capolavoro di Miguel de Cervantes sono culminati, nel 1990, nell’allestimento
di un monumentale spettacolo per gli spazi aperti, diretto da Cora Herrendorf,
che fino al 2008 è stato presentato oltre quattrocento volte in decine di
Paesi. Herrendorf è morta a inizio 2023, in occasione dei cinquant’anni del
gruppo la figlia Natasha Czertok e il padre Horacio (anche interprete del ruolo
principale) hanno deciso di far rinascere questa creazione: un Canto alla
durata, per dirla con il poeta Peter Handke, che interroga la temporalità
insita nell’arte della scena per motivi più poetici che di economia, più
politici che personali. Protagonista a parte, tutte le persone in scena sono
mutate: oggi il giovane cast dà vita ai continui, repentini cambi di ambiente e
costume con energica dedizione e muscolare duttilità. L’arcinota vicenda viene restituita,
o meglio suggerita, mediante una serie di quadri giustapposti: viaggi e
incontri, rapimenti e salvataggi, imboscate e fughe, vittorie e sconfitte,
prigionie e liberazioni. Sbagliato sarebbe far confronti fra i due allestimenti:
e se ritrovare una creazione che segnò radicalmente il nostro sguardo sul
teatro, dunque sul mondo, non può non far ricordare, ad esempio,
l’indimenticabile Sancho incarnato da Antonio Tassinari, la ridda di
accadimenti, suoni, luci, materiali poveri messi in vita dal manipolo di corpi-in-azione
riporta all’essenza del teatro come incontro tra umani in un ineludibile qui e
ora. Infine: questo Quijote! non manifesta unicamente il gusto per
il letterario e per il picaresco, per i guizzi e la grandeur scenica,
ma rappresenta un’allusione ai vizi del tempo, alla corruzione dei costumi, al
disfarsi di un mondo e, al contempo, all’inesausta voglia di costruirne
uno altro e alto, da dentro. Sorprende, avvince,
fa ridere, fa paura. Quel che più conta: è esercizio di rivoluzione.
Michele Pascarella
---
Recensione di zona de derrama - first chapter di Catol Teixeira, p. 74.
Alleanza di
corpi, di anime: su zona de derrama – first chapter di Catol Teixeira
ZONA DE DERRAMA – FIRST CHAPTER, concept, coreografia e performance Catol Teixeira. Co-coreografia e performance Auguste de Boursetty, Luara Raio. Performance sonora Ágatha Barbosa. Creazione sonora Luisa Lemgruber. Prod. Association UÀ. Coprod. RESO - Swiss coproduction found.
Per il terzo anno
consecutivo una creazione di Catol Teixeira è posta in apertura di
Santarcangelo Festival. Nel 2024, ancor più che in passato, ciò pare avere
valore programmatico, quasi un manifesto di temi e stilemi al cuore della
manifestazione diretta da Tomasz Kireńczuk, in particolare rispetto a
liquefazione e ibridazione di codici, linguaggi e identità in nome di una
esperienza da vivere in primis attraverso i sensi, collettivamente, nel
qui e ora. Dopo due assoli nelle precedenti edizioni, Teixeira presenta un trio
in cui l’erotizzazione e la comunione dei corpi in scena persegue la
possibilità di una piena vivezza, a render plausibili e significanti materiali
coreografici sospesi, rarefatti, a tratti apparentemente staccati. Baci e
contatti, brevi sincroni e sguardi d’intesa abitano uno spazio bianco e aperto.
Rumore bianco a far da paesaggio, poi progressivamente il suono diventa
battente, il ritmo aumenta. Ogni corpo è e fa per sé, ma agisce vicino agli
altri. Arrivano spinte e abbracci, sgomitate e carezze. Sollevarsi e portarsi
per qualche metro, a costruire biograficamente e biologicamente -e ad offrire
allo sguardo del pubblico- la possibilità di compassione, dunque di un comune
sentire. Coreografia come traccia percepibile di una meticolosa attenzione, di
una smisurata fiducia reciproca. Di un’alleanza. Una salvifica ironia, a
tratti, giunge a compensar lo struggimento. L’acqua è elemento primordiale in
scena, bagna le teste e trabocca: la si guarda esondare, lo si lascia accadere.
Alcune dinamiche reiterazioni stanno ad esporre, a render percepibili la fatica
e la nudità dei corpi o, meglio, e delle anime: «Ma se il corpo non è l’anima,
l’anima cos’è?» si e ci domandava Walt Whitman e Teixeira, probabilmente,
sarebbe d’accordo. Sul finale tre corpi altri, e vivi, semplicemente stanno.
Spettacolo indefinibile e indimenticabile. Struggente e bellissimo.
Michele Pascarella
---
Recensione di Pas de deux di Anna-Marija Adomaityte, p. 74.
Pas de deux
di Anna-Marija Adomaityte. O la prevaricazione del codice
PAS DE DEUX, concept
e coreografia Anna-Marija Adomaityte. Con Romane Peytavin, Victor Poltier. Sound
e light design Gautier Teuscher. Prod. Cie A M A (LITUANIA, SVIZZERA).
In principio fu Blaubart.
Era il 1977, e Pina Bausch attraverso un dispositivo dissonante e feroce
metteva in scena la violenza dell’uomo sulla donna. Mezzo secolo dopo, filtrata
da progressive concettualizzazioni, la coercizione si sintetizza e al contempo
si allarga. Vittime sono due figure danzanti: lui e lei, jeans e maglietta e
scarpe da ginnastica, una bellezza da rotocalco, si sarebbe detto una volta,
del tutto normale e normata. Si mostrano appiattiti in una delle posture più
genericamente riconoscibili del codice ballettistico. Danno corpo a un
raggelato tableau vivant in cui, occhi sbarrati e muscoli tesi, materializzano
un immaginario coreutico, e più genericamente una convenzione sociale e
culturale, a cui per cinquanta densi minuti, con concreto sforzo fisico,
provano cineticamente ad aderire. Tappeto blu elettrico, sopra di loro grandi
neon rettangolari da sala operatoria, tutt’attorno una musica sintetica,
battente, avvolgente. Lui ripetutamente la sposta, ruotando sul posto, con
rigida bruschezza, come senza opinione, come per mostrarla -e mostrarsi- al
pubblico disposto sui quattro lati dello spazio scenico, nonluogo che si
fa di colpo teatro anatomico: l’oppressione della regola è testimoniata e al
contempo legittimata dalle persone guardanti. Ogni tanto i due si fermano, di colpo.
Come animali in gabbia o al circo, o come insetti schiacciati nei vetrini di un
microscopio, stanno in vibrante immobilità, per poi ricominciare l’insensata
rotazione, la feroce ostensione. Adomaityte crea un dispositivo teso, in cui il
segno coreografico che consegna è al contempo chiarissimo e interpretabile, veemente
ma mai predicatorio: limpido e stratificato come un Concetto spaziale di
Fontana, non impone una univoca lettura, è significante che contiene e rilancia
molti possibili significati. Noi si è avvolti e avvinti dall’agone tra sforzo e
forma, tra biologia e codice. Alla fine molto, molto lentamente cala la luce,
su quel campo di battaglia, a dar spazio al buio che abitiamo. A dar forma al
buio che siamo.
Michele Pascarella
---
Recensione di Il Mio Filippino: The Tribe di Liryc Dela Cruz, pp. 74-75.
Il Mio
Filippino di Liryc Dela Cruz: guardare non è più un atto innocente
IL MIO FILIPPINO: THE
TRIBE, ricerca, concept, testi, coreografia, direzione Liryc Dela Cruz. Con
Sheryl Pabalcal Aluan, Jenny Llanto Caringal, Benjamin Vasquez Barcellano Jr.,
Tess Magallanes.
«Guardare non è più
un atto innocente»: si potrebbe sintetizzare con il claim dell’edizione 2015 di
Santarcangelo Festival, l’installazione performativa dell’artista filippino Liryc
Dela Cruz. Tema, nomen omen, il nostro (in)consapevole sguardo
colonialista che relega un popolo a mera (sotto)categoria umana servizievole e
sorridente. Ciò è rappresentato, per la maggior parte dei 70 minuti di questa indimenticabile
creazione, attraverso una serie di documentari in bianco e nero, la cui
velocità è a tratti forzata, e da un piccolo gruppo di performer impegnati a
compiere una serie di ripetitive azioni di servizio. Contano in inglese da uno
a otto e da otto a uno, ossessivamente, mentre un po’ alla volta, mediante una
marziale coreografia dal sapore militaresco e dall’effetto spersonalizzante,
spostano un enorme cumulo di detriti posto al centro dello spazio scenico (come
non pensare alla Venere degli stracci di Pistoletto?). Il dispositivo progressivamente
muove, punteggiato da alcune minime variazioni, dalla rappresentazione alla
presentazione dell’alienante compito: vien da ricordare, un esempio tra mille,
quando Jannis Kounellis nel ’69 fece trasportare dodici cavalli vivi in una
galleria nel centro di Roma, riconducendo il fatto artistico alla
responsabilità del guardante di accogliere la realtà quale essa è senza la
consolazione di una sua ben fatta rappresentazione. Tale scarto etico ed estetico
si manifesta con cruda nettezza sul finale: si accendono le luci di sala, una
voce registrata segnala la possibilità di avvicinarsi ai performer i quali, ora
in azione all’interno di uno spazio ancor più circoscritto delimitato da un
velatino colorato, continuano a contare -ora in italiano- e a lavorare. A ogni
persona è consegnata, ineludibilmente, la responsabilità del proprio guardare,
o del non guardare più: continuare a osservarli -come in un’Esposizione
coloniale, o come bestie in gabbia- o lasciarli lì a lavorare e andarsene a
mangiare un gelato? La scena, eloquentissima ancorché muta, rilancia la
radicale questione: guardare non è più, davvero, un atto innocente.
Michele Pascarella
---
Recensione di Officina Oceanografica Sentimentale di Compagnia Samovar, p. 80.
La preziosa
wunderkammer marina di Compagnia Samovar
OFFICINA
OCEANOGRAFICA SENTIMENTALE, ideazione e realizzazione Luca Salata. Prod.
Compagnia Samovar (MORI, TN).
È tutto piccolo, in quella che per noi è
stata, senza dubbio, la più grande e preziosa sorpresa di Kilowatt Festival
2024: la Compagnia formata da due sole persone, i fratelli Luca e Davide Salata,
la cittadina trentina -poche migliaia di abitanti- da cui è partito il
minuscolo camper che ha accolto sette spettatori alla volta per offrire a
ripetizione, alle porte di Sansepolcro, quindici minuti di incanto. Un fil
rouge marino connette e rilancia, con limpida semplicità, l’accezione
etimologica di teatro come luogo di sguardi e visioni. Davanti ai nostri occhi
l’artigiano-artista (fortunati i tempi in cui non vi era distinzione
gerarchica, fra questi mestieri!) in una wunderkammer tanto angusta quanto
accogliente dà vita a macchine
celibi, anima pupazzi, mostra piccole materiche invenzioni, per uno spettacolo
«di spatole, rotelle e onde», un Total Theater in miniatura di legno e
metallo, stoffa e colore, luci e oggetti, certo non distante dalle avanguardistiche
sculture autosignificanti di Jean Tinguely, dai delicati equilibri dei mobiles
di Alexander Calder, dalle ironiche e liriche Macchine Inutili di Bruno
Munari e, arrivando al teatro d’oggi, dagli Armadi Sensibili di Antonio
Catalano e -anche tematicamente affine- dal capolavoro di Roberto Abbiati Una
tazza di mare in tempesta. È malinconica e sorridente avventura del quasi
niente quella che -attraverso un precisissimo lavorio di mani e ritmi, di
intenzioni e direzioni- l’artista fa accadere: un viaggio onirico e ironico
nell’altrove, leggero e soffice come una nuvola. Sul finale, con la poesia Dopo
di Erri De Luca, rilancia al futuro la responsabilità del nostro attraversare:
i mari e la Terra, insieme.
Michele Pascarella
---
Recensione di La buca di Nerval Teatro, p. 82.
L’elementare
esercizio beckettiano di Nerval Teatro
LA BUCA, ideazione,
interpretazione, regia Maurizio Lupinelli. E con Carlo De Leonardo. Collaborazione
all’ideazione e costumi Elisa Pol. Disegno luci e direzione tecnica Gianni
Gamberini. Collaborazione artistica Barbara Caviglia. Prod. Nerval Teatro
(ROSIGNANO SOLVAY, LI).
«Lo so che è difficile andare all’indietro, ma ne vale la pena»: si potrebbe sintetizzare con questa battuta pronunciata sul finale, la direzione letteralmente elementare dell’esercizio scenico beckettiano di Nerval Teatro. Sono almeno tre gli elementi costitutivi di una possibile idea e pratica di teatro che questa creazione pare mettere in evidenza. Primo elemento: il rapporto dialettico con la grande drammaturgia. Si sa, uno dei piaceri della fruizione artistica è verificare quanto e come l’artista abbia variato il già noto. In questo caso: diverse figure beckettiane (in primis da Aspettando Godot) sono trattate per rarefazione e giustapposizione di azioni vocali e cinetiche staccate. Lo spazio bianco, occupato da pochi elementi significanti, si fa teatro anatomico in cui osservare due biologie in azione. Secondo elemento: il rapporto creativo con l’alterità. Inscrivendosi in una tradizione novecentesca di teatro come incontro con l’Altro da Sé, Nerval ha fatto del lavoro con alcune specificità umane chiave etica ed estetica del proprio agire. La possibilità offerta da La buca di imbattersi nell’ironica e malinconica grazia scenica di Carlo De Leonardo, attore con Sindrome di Down, è resa plausibile dal rigore di un impianto drammaturgico e registico al contempo severo e accogliente. Terzo elemento: approccio elementare. L’andamento piano, la fluida successione di minimi accadimenti (camminare, appoggiare la valigia e poi la giacca, fischiettare, guardare dentro al proprio cappello, togliersi e rimettersi una scarpa) e la loro episodica reiterazione pongono in piena evidenza alcuni elementi costitutivi del meccanismo teatrale, che lo spettacolo consegna con fiducia fenomenologica: «Una cosa è contenta di essere guardata dalle altre cose solo quando è convinta di significare se stessa e nient’altro» vien da riassumere con Italo Calvino «in mezzo alle cose che significano se stesse e nient’altro».
Michele Pascarella
L’idiota danzato da Saburo Teshigawara e Rihoko Sato
THE IDIOT, direzione, luci, design Saburo Teshigawara. Danza Saburo Teshigawara, Rihoko Sato. Musica Claude Debussy, P.I. Tchaikovsky, Frédéric Chopin, Dmitrij Shostakovovich, Franz Schubert, J.S. Bach, Giuseppe Tartini e altri. Prod. Karas (TOKYO).
Alcune macchie di luce sul fondale, prima azzurre e poi ocra, à la Mark Rothko, suggeriscono il campo di forze entro cui accade
il lirico ed espressivo pas de deux di Saburo Teshigawara e Rihoko Sato. I due, in una scena illuminata da luci senza posa tremolanti a render
vibratile ogni passaggio, danno vita a un concerto di danze proteiforme, sempre
in bilico tra estremo rigore ed efficacia comunicativa. Camicia bianca, giacca
e pantaloni scuri lui, abito scuro lei, rimandano a un immaginario,
nell’utilizzo di brani della grande Storia della Musica occidentale, che fa
pensare agli ultimi anni di Kazuo Ōno: con il correttivo, in questo caso, di dialogare con le composizioni musicali in direzione
ritmicamente e tonicamente didascalica, con la coreografia che sempre ne asseconda
l’andamento. Non è danza narrativa,
né ricorre a parti recitate: al di là di
alcuni passaggi quasi mimati in cui l’interprete in maniera esplicita manifesta
alcune elementari incapacità (ad esempio non riuscire ad indossare la giacca), rimane
sottotraccia il rapporto significante con il capolavoro di Dostoevskij. Il dato più sorprendente di questa creazione è la
siderale qualità di movimento di questi due «corpi-teatro», per dirla con
Jean-Luc Nancy: è la millimetrica precisione nella segmentazione del busto e
degli arti, nella costruzione e decostruzione di equilibri e disequilibri
interni e di coppia, nella dislocazione del peso nello spazio a rendere il loro
lavoro esemplare. Nota a margine: Teshigawara è stato insignito, nel 2022, del Leone d’Oro alla carriera della Biennale
Danza; Sato,
scenicamente affatto equivalente e complementare, è definita «sua “musa” e storica collaboratrice»:
il maschilismo, anche nelle arti, è ahinoi molto duro a morire.
Rito ultra-romagnolo e universale, per Luigi Dadina
SATURNO FIGLIO DI ANARCHIA, di Cesare Albertano e Luigi Dadina. In scena Paolo Baldini, suoni, musiche, rumori e oggetti e Luigi Dadina, narratore. Scene e costumi Elvira Mascanzoni e Pietro Fenati. Disegni Davide Reviati. Prod. Teatro delle Albe (RAVENNA).
Dalla «vibrante immobilità» del suo imponente corpo-teatro, posto a lato del grande tavolo di legno scuro su cui un musico-officiante pacatamente dispone una selva di bicchieri, affiora una ridda di figure -del mondo e del teatro- che da quarant’anni e più Luigi Dadina accoglie e traduce in arte del racconto e dell’incontro. Saturno figlio di Anarchia sintetizza temi e stilemi del suo fare arte e fare comunità, prassi indistinte in un teatro che «mette in vita», come da sempre si dice nella tribù delle Albe, parole e biografie. Lo spettacolo, nato da una richiesta della vedova di Saturno Nino Carnoli, racconta la vicenda di questo indomito ravennate procedendo -in una colta drammaturgia che giustappone etimologie e avventure, invettive e meditazioni, ricordi e racconti, Hesse e Moretti, Calvino e Borges, giovani e vecchi, padri e figli- per vie rizomatiche che paiono far affidamento tanto al paziente artigianato quanto alla fulminea intuizone. Si è in cerchio, in questo umanissimo rito al contempo ultra-romagnolo e universale, «tutti immersi nella stessa luce»: diviso in sette quadri, cadenzati dallo scorrere di immagini alla maniera dei cantastorie tradizionali, si raccontano vicende antichissime e recenti, dai Saturnalia alle morti per Covid, accomunate dagli incontri che, da sempre, muovono il fare di Dadina. In mezzo al grande spazio circolare vi è un mazzo di rose rosse, il cui profumo è più volte evocato nel racconto: una festa del noi è questo teatro antico, fuori dalle mode e dal tempo, ancorché radicalmente inscritto nel qui e ora di ogni persona che lo incontra. O, meglio, che lo fa esistere. Come lo storico Cesare Albertano, con la sua lieta sapienza; come Davide Reviati, le cui illustrazioni hanno accompagnato più d’una creazione di Dadina; come Elvira Mascanzoni e Pietro Fenati, che da decenni condividono l’avventura di Ravenna Teatro. È un monologo popolato, Saturno figlio di Anarchia, «contiene moltitudini», si potrebbe dire parafrasando Walt Whitman: bisogna saperlo fare. Bisogna volerlo fare.
Michele Pascarella
---
Recensione di Cenere del Teatro delle Bambole, p. 84.
Deledda e Nitsch: il teatro come rituale
CENERE, di Grazia Deledda. Regia Andrea Cramarossa. Aiuto regia Federico Gobbi. Costumi Silvia Cramarossa. Prod. Teatro delle Bambole (BARI).
È programmaticamente
primitivo e didascalico, ciò che il Teatro delle Bambole ha tratto, con il
consueto visionario rigore, dal romanzo di Grazia Deledda che meritò l’unica
interpretazione cinematografica di Eleonora Duse. Lo spettacolo è parte di un
composito progetto di ricerca che indaga -con gittata pluriennale, come
consueto per questo appartato quanto radicale ensemble indipendente- cosa può
accadere quando la Letteratura diventa Teatro. Dopo i recenti attraversamenti
di Dostoevskij e Calvino, l’affondo nella scrittura rocciosa, naturale e impervia dell’autrice sarda dà luogo a un accadimento analogamente
primitivo, nel senso letterale dell’essere teso alla creazione di un «luogo
originario». In un dispositivo scenico scabro sta una Persona a più strati
mascherata (forse per ricordare che nell’etimologia della parola «persona» vi
sono «maschera, personaggio»?) che mette a disposizione del testo tutti i segni
di cui è portatrice: vocalici, posturali, cinetici. Il rapporto
intenzionalmente didascalico con il romanzo, ossia il far aderire tutti gli
elementi di significazione al testo di cui lo spettacolo si nutre, è reso
sottilmente stratificato da continui, minimi, esattissimi slittamenti temporali
posti in essere da Michele Lamberti, l’enigmatica e malinconica Über-Marionette
che incarna e al contempo si lascia attraversare dal racconto. Sul finale, dopo
una lunga sequenza di scene staccate in cui brusche variazioni di campiture
luminose monocrome concorrono a dar secchezza a quanto è offerto allo sguardo,
alcuni materici colori vengono versati su una tela bianca, a evocare i relitti di Hermann Nitsch, la cui prassi di teatro come rituale misterico e
trasformativo da sempre nutre la poetica di questo ensemble. A significare, si
potrebbe concludere parafrasando Gertrude Stein, che «un racconto è un racconto
è un racconto».
Michele Pascarella
---
Recensione de L'incoronazione di Poppea diretta da Pier Luigi Pizzi, p. 91.
L’incoronazione pop di Pier Luigi Pizzi
L’INCORONAZIONE DI POPPEA, di Claudio Monteverdi. Regia, scene, costumi e luci Pier Luigi Pizzi. Orchestra Monteverdi Festival – Cremona Antiqua, maestro concertatore e direttore Antonio Greco. Con Roberta Mameli, Federico Fiorio, Josè Maria Lo Monaco, Enrico Torre, Federico Domenico Eraldo Sacchi, Candida Guida, Chiara Nicastro e altri 7 interpreti. Prod. Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, CREMONA. In coproduzione con OperaLombardia, Teatro Verdi di Pisa, Teatro Alighieri di Ravenna.
In accordo con l’origine impresariale del capolavoro monteverdiano, l’allestimento diretto con vibratile slancio comunicativo dall’ultranovantenne Pier Luigi Pizzi si porge alla platea con una varietà di colori (nei costumi scintillanti così come nell’interpretazione vocale e attorale) a intridere la funestata storia d’amore tra Poppea e Nerone dando luogo a una vera festa, per gli occhi e per le orecchie, commovente nel senso etimologico del trascinare con sé, fino all’apoteosi del celeberrimo amplesso vocale finale Pur ti miro, pur ti godo, per le quasi quattro ore di rappresentazione. Pizzi ambienta la fabula in un luogo dal sapore metafisico a bilanciare sapientemente, nel minimalismo geometrico di praticabili, colonne e sfere, le molte passioni che la attraversano. In primis la sensualità con cui Roberta Mameli e Federico Fiorio caratterizzano i ruoli (principali) che son chiamati a sostenere -lei più prorompente, lui più indefinito- ma anche la sferzante ironia di molti passaggi, tra cui una minuscola quanto memorabile controscena in cui la nutrice, interpretata da Danilo Pastore, gioca con il velo di Ottavia con una sapienza ritmica e immaginativa da manuale: questo esempio fra molti, a mo’ di sineddoche, a sintetizzare la vivezza e la cura che percorre tutta l’opera, in un continuum di tensioni e rilasci, momenti drammatici e leggiadri, slanci e ritrosie. Tra amori, tradimenti, tentati omicidi e cospirazioni d’ogni genere la vicenda evolve rilanciando la centralità della vocalità e delle sonorità monteverdiane, intrise di madrigalismi e progressioni, nonché le mille sfumature -riccamente barocche, è proprio il caso di dire- del libretto di Giovanni Francesco Busenello. Chapeau.
Michele
Pascarella
L’enciclopedica carità di
Angélica Liddell
CARIDAD. UN’APPROSSIMAZIONE ALLA PENA DI MORTE DIVISA IN 9 CAPITOLI, testo, scene, costumi e regia Angélica Liddell. Prod. Iaquinandi S.L, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Festival Temporada Alta Girona, CDN Orleans Centre Val de Loire, Teatros del Canal Madrid, in collaborazione con Aldo Miguel Grompone, Roma.
«Non
sono venuto a portare pace, ma una spada»: il frammento del Vangelo di Matteo, testo
a cui Angélica Liddell a più riprese si riferisce, pare utile a introdurre la
recente creazione dell’alchemica artista spagnola.
Inscrivendosi nel fil
rouge di suoi temi e stilemi, il discorso scenico che crea a partire dalla carità
del titolo non ha nulla di pacificato né pacificante: furie vocaliche e
cinetiche si giustappongono a crude nudità e il racconto di feroci barbarie si
succede alla brusca ostensione di peculiari disabilità, umane e animali.
Questo incandescente
materiale è trattato, a partire dalla suddivisione in capitoli, in senso
enciclopedico, brechtianamente didattico ed eticamente interpellante.
A partire dalla personale
aderenza alle ossessioni messe in scena (in tal senso Caridad può essere
considerato la nuova pagina di un canzoniere autobiografico che l’artista va
componendo, di spettacolo in spettacolo), Liddell pone una salutare, linguistica
distanza.
Sono infatti la lingua e
la storia delle arti e della cultura ciò che viene enciclopedicamente offerto ai
sensi e al pensiero.
Una successione di scene
staccate in cui il rapporto del corpo con altri corpi e con lo spazio si
articola in maniera ora conflittuale, ora pacificata.
Molte esplicite
citazioni: Bataille, Steiner e Foucault, ma anche
Beckett, Pasolini, Godard e Dreyer tra gli altri (curiosamente, tutti uomini).
Ancora, L’origine del mondo di Courbet e Rest Energy di
Marina Abramović e Ulay, con il correttivo della punta della freccia rivolta al
cuore: ha le sembianze di un grosso pene.
La glossolalia (in una
scena folgorante ai limiti della Body Art) che evoca il situarsi del linguaggio al di fuori delle leggi della comunicabilità
e, al contempo, la tensione a rivolgersi ineffabilmente al divino.
Body Art e storia
della performance in altri evidenti rimandi: il Teatro delle Orge e
dei Misteri di Hermann Nitsch, in primis, per il rapporto trasformativo -alchemico, si diceva- di metalli vili
in oro. La bassezza del corpo corrotto e corruttore è il luogo da abitare e attraverso
il quale trascendersi: approssimando la
(pena di) morte ma anche il mistero, e la grazia, dell’espressione.
Michele Pascarella
---
Recensione di Gaia di ErosAntEros, p. 67.
L’urlo
ambientalista di ErosAntEros
GAIA, drammaturgia Agata Tomšič. Regia e music design Davide Sacco Con Agata Tomšič e un gruppo di attivisti climatici. Video Francesco Tedde. Costumi Arianna Fantin. Luci Marco Rabiti. Prod. Ravenna Festival, ErosAntEros – POLIS Teatro Festival (RAVENNA).
«Fermatevi!»: con questa perentoria ingiunzione si chiude la nuova creazione di ErosAntEros che, rispetto alle precedenti produzioni, presenta almeno tre elementi di continuità e tre novità. Dal punto di vista tematico permangono l’attraversamento partecipe di questioni della contemporaneità, per un teatro con contenuti sociali e politici espliciti; compositivamente si conferma la complementarietà di autorialità e funzioni (Sacco regia e music design, Tomšič drammaturgia e interpretazione); scenicamente si consolida il dar luogo a forme rituali scevre da qualsiasi ironia, termine da intendersi sia nell’accezione comune di affine all’ilarità sia in quella socratica di distanza fra il soggetto e ciò di cui tratta. Costutiscono invece tre aspetti inediti, ancorché inevitabilmente connessi al percorso iniziato nel 2010, l’interpellazione diretta agli spettatori (di cui il «Fermatevi!» in chiusura è sintesi e sineddoche; la presenza in scena, in funzione di coro, di un gruppo di attivisti climatici; un’ancor più radicale connessione tra etica ed estetica, che si esplicita ad esempio in una stupefacente scenografia “smaterializzata” di fumo, luci e proiezioni video che permetterà a questa creazione di viaggiare a basso impatto ambientale. È teatro che abita la meraviglia, ma a fini politici: come non pensare al Montaggio delle attrazioni teorizzato da Ėjzenštejn, là dove parla di uno «spettacolo-fantasmagoria» che deve «agire efficacemente sullo spettatore con tutti i mezzi messi a disposizione dalla tecnica moderna»? Lo stratificato, colto e al contempo esplicito discorso che ErosAntEros pone qui in essere sui temi ambientali ha debuttato al Ravenna Festival a poche settimane dall’alluvione che ha colpito la Romagna: anche se il progetto scenico della Compagnia era ovviamente di gran lunga antecedente, si conferma la volontà di abitare un’arte, concretissima e al contempo ineffabile, che si fa sonda e scandaglio delle questioni che attraversano il nostro presente.
Michele
Pascarella
---
Recensione di Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi, p. 70.
Guenzi one man show
UNO SPETTACOLO DIVERTENTISSIMO CHE NON FINISCE ASSOLUTAMENTE CON UN SUICIDIO, di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi. Regia Nicola Borghesi. Con Lodo Guenzi. Consulenza drammaturgica Daniele Parisi e Gioia Salvatori. Prod. Argot Produzioni (ROMA), Infinito Produzioni (SANSEPOLCRO).
Per quasi due ore
canta, ride, racconta spostando scenografie, suona il pianoforte e nel bis
anche la chitarra. Ambientazione e patto scena-platea da one man show:
scintillii e istrionismo, ritmo e ironia, il piacere di ammirare un personaggio
famoso (tipico segnale: l’applauso di sortita) e quello di essere ammirato. Oggetto:
l’esperienza biografica di Guenzi, dalla scuola media a Sanremo, dai fan
fastidiosi in autogrill alla giuria di X Factor, dal training all’Accademia di Arte Drammatica a Risveglio di primavera di Wedekind. E tanto, tanto
altro, offerto in un profluvio inarrestabile di gesti(colazioni) e parole. Il
pubblico, Guenzi, lo tratta «con quella pacata amara indifferenza dell'attore
che conosce i polli della
sua platea», come direbbe Ennio Flaiano: fa cantare un brano di Jovanotti, fa ripetere in coro «Bisogna
parlare a tutti», lo sfotte come il più consumato dei clown e al contempo ne
incoraggia la benevolenza dichiarando a più riprese, con voce esitante, le sue
incapacità. Il pubblico -da sold out- sta al gioco, divertito dalle continue
battute che sempre tendono all’arguzia e al disilluso, sminuente cinismo su
tutto e tutti, in una complicità «verso il basso» intrisa di voyeurismo e gossip, con un linguaggio oltremodo diretto e colloquiale che senza
posa tende al turpiloquio: «E poi le parolacce
che ti lasci scappare che servono a condire
il tuo discorso d'autore», si potrebbe sintetizzare con
l’Ivan Graziani di Pigro. Lo spettacolo è aperto da un
paio di prologhi e chiuso da una moltiplicazione di finali (con la classica
sequenza aumento progressivo del pathos - sospensione): in mezzo una quantità
di cambi di ritmo e di tono marcatissimi, scevri da qualsiasi sfumatura, e pochi
momenti emotivamente connotati sottolineati da musiche e luci intense. Son
certo lontani i tempi in cui con il teatro si voleva cambiare il mondo e forse
anche quelli in cui l’autobiografia costituiva una materia che solo un rigoroso
trattamento linguistico poteva rendere fatto d’arte. Tant’è.
Michele Pascarella
Il pas
de deux di Elena Bucci e Angela Malfitano
In sintesi: tra nostalgia e ironia, un duetto ad opera di due
donne di teatro.
Partiamo dal fondo.
Teatro: sono affatto teatrali l’universo di esperienze
autobiografiche a cui senza posa si attinge, così come la relazione scena-platea,
che si costituisce di fascinazione per le attitudini affabulatorie delle
interpreti e di una ridda di figurazioni costruite a vista, in primis
tramite l’interazione fisica e verbale tra questi due corpi-teatro. La drammaturgia
si sviluppa per giustapposizione e sovrapposizione di immagini e immaginari,
elucubrazioni e lacerti narrativi, a rendere rizomatico e sognante ciò che è offerto
all’ascolto.
Donne: sono marcatamente femminili sia l’oggetto del racconto
sia l’attitudine massimamente accogliente di stati d’animo e sentimenti, che in
questo dispositivo acquistano valore comunicativo in quanto tradotti in linguaggio
scenico.
Opera: Per magia mostra il proprio farsi, non cela la
struttura linguistica che ogni accadimento teatrale sostiene. Ricorda il tempo
il cui tra arte e artigianato non vi era differenza, né nella terminologia né
nei fatti.
Duetto: è un pas de deux in cui le Figure sono al contempo
complementari e compenetrate in un unicum inestricabile. Ciascuna in
scena è e incarna anche l’energia, i ricordi, l’affannarsi dell’altra.
Ironia: termine da intendersi, in questo caso, sia nel senso
socratico di mettere distanza, anche temporale, tra sé e ciò di cui si parla o si
evoca, sia nel senso comune di produrre ilarità. Si sorride spesso, di e con
queste due improbabili, esagitate, fragili figure del mondo.
Nostalgia: sottotraccia vi è, etimologicamente, un “dolore
del ritorno” che informa di sé ogni evocazione e ogni smemoratezza, le vite non
vissute e quelle a cui negli anni le due autrici hanno dato corpo, voce, anima.
Per magia, in definitiva,
è una grande dichiarazione d’amore per il teatro: “Non esiste un luogo migliore
di questo”, sussurrano.
“Il migliore dei mondi possibili”, ha detto qualcuno: qui e ora, qui e allora.
Michele Pascarella
Lo Stabat
mater iconoclasta di Chiara Guidi
STABAT MATER, di Jacopone da
Todi. Azione per due voci e chitarra elettrica di Chiara Guidi, Giuseppe
Ielasi, Vito Matera, Anna Laura Penna e Francesco Dell’Accio. Prod. Societas (CESENA).
“Stabat mater è una preghiera che mettiamo in scena e
componiamo affidandoci all’improvvisazione”: questo avvertimento è posto in
apertura del foglio di sala che, oltre ai crediti dello spettacolo, riporta unicamente
il testo attribuito a Jacopone da Todi, forse a significare che quelle parole
sono il principale elemento fisso, o almeno comunicabile, di questa creazione.
Ciò non faccia pensare a una sorta di sudditanza “testo-centrica”:
in questo, come in molti altri accadimenti nella pluridecennale parabola
esplorativa della co-fondatrice della Societas, le parole funzionano come trampolino,
direbbe Grotowski, di un gesto scenico sideralmente distante da qualsiasi
illustrazione, in cui i segni (verbali, para-verbali, sonori, visuali) vengono
consegnati allo spettatore con l’oggettività di un fatto.
Pare corretto definire “etimologica” questa versione (la
parola preghiera contiene nella propria origine l’aggettivo precario)
in cui due interpreti al leggio -la stessa Chiara Guidi insieme a Anna
Laura Penna- danno corpo a un impasto vocale e vocalico teso a intrecciare diverse
versioni dello Stabat mater con i suoni elettrici della chitarra di
Giuseppe Ielasi, producendo vibrante movimento percettivo in una scena
altrimenti immobile, affondata nella semioscurità.
L’enigmatico concerto prelude
a una muta azione scenica, interpretata da Francesco Dell’Accio, complementare
e conseguente: questa, come quello, è una meditazione sulla morte al contempo
invocante e iconoclasta.
Un soldato, intrappolato in una stanza, scruta fuori da una finestra, nel buio, sputa sulla propria uniforme, toglie dalle pareti alcune immagini appese (tra cui una rappresentazione della Madonna con Gesù), scopre una Figura defunta (la madre?): inscritto in una genealogia da far tremare i polsi -da Desprez a Palestrina, da Scarlatti a Vivaldi, da Pergolesi a Haydn, per citare alcuni fra gli oltre trecento compositori che nei secoli si sono cimentati con lo Stabat mater- questo concerto scenico si caratterizza per programmatica tensione iconoclasta alla libertà creativa, condizione che si basa in primis sull’acuta attenzione alla mutevole realtà, della scena et ultra.
Michele Pascarella
Recensione di La mite del Teatro delle Bambole, pp. 82-83.
Il Dostoevskij espressionista del Teatro delle Bambole
LA
MITE, dall’omonimo racconto di Fëdor Dostoevskij. Adattamento del testo,
allestimento e regia Andrea Cramarossa. Con Federico Gobbi. Prod. Teatro delle
Bambole (BARI).
Con il chirurgico equilibrio tra eccesso e misura che gli è proprio, il Teatro delle Bambole tratta il «racconto fantastico» di Dostoevskij in chiave marcatamente espressionista: recitazione esasperata con toni spesso ai limiti dell’esaltazione, insistite iterazioni (già presenti nel testo di riferimento, qui smembrato e riassemblato rispettandone rigorosamente lo stile e l’andamento sincopato), cambi netti di luce monocroma (ora bianca, ora arancione, ora verde, senza sfumature), ombre che si stagliano nello spazio scenico a rendere le ossessioni del protagonista etimologicamente teatro, cioè luogo percepibile di sguardi e visioni. Il delirante monologare di fronte al corpo della giovanissima moglie, suicidatasi poche ore prima gettandosi dalla finestra, in questa trascrizione scenica assume connotati legnosi, cupamente burattineschi: l’interprete è chiamato a eseguire una precisa quanto spigolosa partitura di gesti spezzati che ossessivamente si reiterano, secchi balzi in avanti sulla sedia, rotazioni improvvise, scarti repentini del tono di voce e muscolare, interagendo con un tappeto sonoro che, analogamente, procede per stacchi improvvisi. L’uomo, indossando un povero costume dalle fattezze soldatesco-carnevalesche, utilizza alcuni oggetti -un violino, un cavallo di legno con il corpo ricavato da un manico di scopa, una spada giocattolo- con infantile assolutezza: tutto ciò che vive, e che lo circonda, è in bianco e nero. Con feroce, «severa meraviglia» ogni suo dire e fare si manifesta come il traboccare delle ombre che lo pervadono: non “dire, fare”, piuttosto “non poter non dire, non poter non fare”. Come non pensare a Sul teatro di marionette in cui Kleist mise in scena, attraverso una sequenza di contraddizioni e paradossi, il rapporto tra Animato e Inanimato e, dunque, con il sovrasensibile?
Michele Pascarella
La terribile grazia dei Numeri di
Lenz
NUMERI,
drammaturgia, imagoturgia Francesco Pititto. Composizione,
installazione, involucri Maria Federica Maestri. Musica
originale Andrea Azzali. Interprete Marcello Sambati. Prod. Lenz
Fondazione (PARMA).
Senza mediazioni né ammicchi. Sideralmente distante da qualsiasi narrazione e sentimentalismo è, sempre più radicale, la ricerca linguistica di Lenz. Elemento di novità, nel più recente approdo di questa indagine (come di consueto parte di un più articolato progetto pluriennale, in questo caso sulla letteratura del sacro nella religione cristiana), è la collaborazione con Marcello Sambati, poeta, regista e drammaturgo dal percorso rigoroso e appartato, per attitudine poetica e politica in piena sintonia con l’universo immaginifico e incubotico in cui è qui immerso. La composizione scenica pone in dialogo, creando continui cortocircuiti semantici, coppie di opposti. Tre esempi nella relazione tra suono e azione (ma molti sono i piani che si potrebbero intrecciare): il pianto di un infante accompagna l’incedere del vecchio corpo seminudo di Sambati, frammenti sonori ritmici la sua immobilità, passaggi musicali sospesi, finanche rarefatti, parti di testo che nominano sudore, lavoro, calore. Allargando: elementi che rappresentano altro (a partire dagli stessi Numeri) dialogano con fatti che valgono in primis in quanto tali, al di là di ogni rappresentazione (uno su tutti: il corpo-teatro di Sambati, che ha la consistenza scenica oggettiva di un danzatore butō). Su pannelli ai tre lati dello spazio è presentata la scrittura di immagini che, in un obliquo susseguirsi di dipinti, elementi naturali e geometrici avvolge l’accadimento in cui ci si trova immersi: Numeri si pone come opera d’arte totale, in cui le varie componenti del fatto scenico (il testo, l’attore, i suoni, l’installazione materica, le immagini, ecc) parimenti concorrono a creare un sistema di segni immersivo e poetico. È teatro di poesia, Numeri, che approssima con rigorose visioni la terribile grazia dell’espressione.
Michele Pascarella
Il
barocco contemporaneo (e battagliero) di Commune
COMMUNE, ideazione e regia Maria Magdalena Kozłowska. Performance Teresa Costa, Maria Magdalena Kozłowska, Beatrice Miniaci, Maayan Licht, Aleksandra Wtorek, Béatrice Picard. Costumi e allestimento Jan Tomza-Osiecki. Luci Julian Maiwald. Libretto Aldona Kopkiewicz, Maria Magdalena Kozłowska. Drammaturgia Aldona Kopkiewicz. Prod. Frascati Producties (AMSTERDAM).
«Nacque un altro leggiadro pensiero
/ per negare si rigido impero»: un minuscolo frammento da Il trionfo del
tempo e del disinganno, celeberrimo oratorio di Georg Friedrich Händel, è
uno dei pochi elementi riconoscibili di Commune, sorprendente creazione
di Maria Magdalena Kozłowska
presentata per la prima volta in Italia a Santarcangelo Festival 2022.
Tema centrale è la ribellione: ciò
è manifestato a svariati livelli, che si integrano in un unicum inclassificabile e del tutto ammaliante.
Vi sono alcuni riferimenti visivi a
contestazioni dell’oggi (striscioni appesi in platea con frasi dal sapore
militante, passamontagna a coprire il volto delle performer, cartelli agitati
fra il pubblico, ...), vi è il racconto, intriso di tagliente ironia, di
esperienze familiari di dissenso, tra infanzie ribelli e nonne comuniste ma,
soprattutto, vi sono elementi divergenti e stranianti sul piano del linguaggio
scenico.
Se è vero che la storia dell’arte è
innanzi e soprattutto storia delle forme, del come, il principale merito di Commune è trattare
il tema scelto a livello di significante.
Tra artiste che eseguono brani a testa in giù, o muovendosi su un tappeto elastico, o impegnate in altre spiazzanti contorsioni; un sorprendente sopranista che rinnova qualche salutare dubbio sulle categorie binarie che ordinariamente regolano la nostra classificazione del mondo (uno dei nodi indagati dallo spettacolo e dal Festival tutto); l’ambiente installativo cupo, onirico e indefinibile in cui le Figure sono immerse; i costumi multicolori e i passamontagna iper-decorati dai cui occhi fuoriescono lunghe ciocche di capelli colorati a evocare un pianto che si fa materia, ancorché dal sapore pop, la rivoluzione (usiamo questo termine non senza tremore) che Commune prova a istituire è l’unica forse, oggi, possibile: dentro al linguaggio, dunque nella nostra ricezione.
Michele Pascarella
Doom: il femminile tra espressione
e repressione
DOOM, coreografia, performance Teresa Vittucci. Composizione, performance Colin Self. Palco Anna Wohlgemuth. Luci Thomas Giger. Prod. OH DEAR! (ZURIGO) e OH DEAR productions (VIENNA).
È un ammutinamento al destino
del titolo, il nuovo spettacolo di Teresa Vittucci, coreografa, danzatrice e
performer viennese di nascita e zurighese d’adozione, nonostante il nome
italiano. Nel nostro Paese non la si vede spesso: Doom è stato
presentato a Santarcangelo Festival in prima nazionale e negli ultimi anni
solamente in un’altra occasione (nel 2021, a Contemporanea Festival) ha proposto
in Italia il suo lavoro; in quel caso Hate me, tender, assolo che dà
avvio alla «trilogia sull’elogio alla vulnerabilità» di cui Doom
costituisce la seconda parte.
Forza e debolezza, rabbia e
dolcezza, eccesso e misura sono le coppie di opposti che questa performance
misteriosa e ammaliante indaga.
In uno spazio scenico in cui i
piani verticale e orizzontale si congiungono senza soluzione di continuità due
conturbanti Figure, «piccoli pieni in mezzo a un grande vuoto» si potrebbe dire
con Beckett, stanno immerse in una luce gialla, marziana: da un altro pianeta
sembra provenire la radicale alterità di questi corpi che si offrono allo sguardo
in piena nudità e molti tremori.
Teresa Vittucci, spogliata dai
fianchi in giù e poi integralmente, esegue una vigorosa partitura a terra di
slanci e rimbalzi, estensioni e reiterazioni. Avanza, arretra, come un animale
in gabbia insofferente e scalciante.
Colin Self, body e orecchie a
punta, articola un canto minimale e dolente intriso di riverberi e sospensioni,
curioso folletto che dichiara la propria alterità.
In diversi momenti i due stanno distesi a terra, per poi ingaggiare un dialogo surreale e comico, filosofico e non-sense dal sapore beckettiano e, sul finale, cantare a due voci, a lungo, una composizione lieve e malinconica, a volume via via più basso. Di colpo le luci si spengono: resta il canto, a chiudere una performance che assume le figure mitologiche di Eva e Pandora a occasione per attraversare i temi del femminile e delle sue infinite espressioni e repressioni per via evocativa più che descrittiva, poetica più che narrativa. Una proposizione enigmatica e indimenticabile.
Michele Pascarella
---
Recensione di Love me di Marina Otero, pp. 74-75.
Il viaggio elementare di Love me
LOVE ME, testo e regia Marina Otero, Martín Flores Cárdenas. Con Marina Otero. Prod. Mariano de Mendonça - Casa Teatro Estudio (BUENOS AIRES).
Love
me è il più recente approdo
performativo di Recordar para vivir,
progetto che nelle intenzioni dell’autrice Marina Otero -regista, performer,
autrice e insegnante argentina ora residente a Madrid- «durerà per l’intero
corso della sua vita».
Lo
spostamento dal Sudamerica all’Europa, al di là dell’occasione biografica,
sintetizza il tópos di questa performance, che racconta
di una condizione di sofferta instabilità, innanzi tutto psico-emotiva e
relazionale, inscrivendosi nella lunga genealogia di autori che tendono a far
coincidere la propria vita e la propria opera.
Love me realizza
tale non certo innovativa attitudine riportando al centro gli elementi
essenziali di molti accadimenti performativi: il racconto, il corpo.
Per quasi l’intera durata di Love me, Otero sta
seduta su uno sgabello a centro scena, praticamente immobile, sguardo a terra,
mentre sul fondale alle sue spalle viene proiettato, nel silenzio, un lungo
racconto, da lei scritto insieme a Martín Flores Cárdenas, che parla di disagio e
oscurità, istinti violenti e patimenti abbandonici, frustrazioni esistenziali e
bisogni affettivi. La scrittura è ritmata e diretta, concreta e avvincente:
frasi brevi, intrise di amara ironia, alternano passaggi intimistici, sorta di
secchi monologhi interiori, e frammenti più esplicitamente rivolti al pubblico.
Nell’ultima parte della performance Otero si alza in piedi
e, al suono di canzonette in lingua spagnola dagli echi pop, traduce in una
danza energica ed eccessiva, sguaiata e commovente durante la quale -non più
solo metaforicamente- si mette a nudo, quanto prima è stato espresso a parole.
Love me, a Santarcangelo Festival, ha radicalmente “diviso il pubblico”: qualcuno lo ha amato, altri lo hanno detestato. Qualunque cosa se ne pensi ha la radicalità, l’assolutezza e le spigolosità di un’invocazione. È l’ostensione di un femminile selvatico e tagliente, senza mediazioni.
Michele
Pascarella
La wunderkammer di DispensaBarzotti
THE BARNARD LOOP, ideazione e
scrittura Alessandra Ventrella e Rocco Manfredi. Regia Alessandra
Ventrella. Con Francesco Napoli. Coprod. DispensaBarzotti (MARSIGLIA) e
Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti (PARMA).
Un uomo attraversa la notte, insonne e muto, in una camera da letto che
progressivamente si rivela luogo vivo di meraviglia e curiosità in continua
trasformazione: una sequenza di piccole azioni, tra minimi stupori e mille
oggetti in-animati, si intreccia con le musiche avvolgenti, le volute di
fumo, le luci colorate ed esatte a creare un universo onirico auto-portante,
sorta di autonomo e surreale teatro-in-valigia che si offre allo sguardo apparentemente
senza scopo. L’interprete, novello Buster Keaton, esegue con malinconica
delicatezza una proteiforme partitura in bilico tra senso e non senso: è un antieroe
assolutamente ordinario, eppure capace di cose grandi o, almeno,
sorprendenti, come lo scomparire, davanti ai nostri occhi, dentro a una valigia
certo troppo piccola per contenerlo. The
Barnard Loop rappresenta un affondo
nella magie nouvelle, nuovo (per l’Italia) approccio performativo in cui
la magia non è semplicemente ciò che accade in scena (come negli spettacoli
tradizionali di questo tipo, composti da una serie di “numeri”), piuttosto ne
costituisce il vero e proprio linguaggio, rendendola autonoma, significante,
finanche narrativa. Ciò non faccia pensare a un’articolazione discorsiva pienamente
intelligibile: come evocato nel titolo, che rimanda a una misteriosa nebulosa
situata nella costellazione di Orione, lo spettacolo procede per rizomatiche suggestioni
problematizzando -attraverso una serie di reiterazioni, minime variazioni,
trabocchetti- l’esperienza della percezione e della ricezione. The Barnard Loop destruttura
“dall’interno” la forma-dramma: nell’apparente rispetto dei suoi statuti (plot,
personaggio, set, …) dà corpo e fa risuonare il lato fantastico, irrazionale, misterioso
di ciò che accade, in scena e in ciascuno.
Michele Pascarella
---
Recensione di Sconcerto per i diritti di ErosAntEros, pp. 72-73.
Il
teatro militante e didattico di ErosAntEros
SCONCERTO PER I DIRITTI, ideazione e spazio Davide Sacco e Agata Tomšič. Con Agata Tomšič ed Emanuela Villagrossi. Drammaturgia Agata Tomšič. Regia, disegno musicale, luci e video Davide Sacco. Disegni Gianluca Costantini. Costumi Laura Dondoli. Prod. ErosAntEros – POLIS Teatro Festival (RAVENNA).
Uno spettacolo che sarebbe piaciuto a Don Milani, che andrebbe presentato nella sua Barbiana, nelle Case del Popolo se ancora ci fossero, nelle scuole, nelle piazze e, certo, nei teatri: ha piglio militante e finalità esortative, brechtianamente didattiche, questa creazione che parte dalla lettura della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per articolare un dispositivo scenico che intreccia etica ed estetica, teatro politico e ricerca linguistica, la cronaca, l’Eneide di Virgilio e le Lettere a Lucilio di Seneca. In scena due performer dalle sembianze marziane articolano con millimetrica precisione una partitura fisica, vocale e percussiva minimale e marziale, a dialogare con immagini dell’oggi e con i disegni dell’artista-attivista Gianluca Costantini, premio “Arte e diritti umani” Amnesty International Italia 2019 (lo spettacolo gode del patrocinio dell’associazione umanitaria), che evocano alcuni protagonisti della cronaca politica odierna, da Greta Thunberg a Carola Rackete, da Matteo Salvini a Giulio Regeni. L’ambientazione extra-terreste, la recitazione anti-naturalistica, la fiera esecuzione di questo Sconcerto creano un’efficace distanza, un salutare raffreddamento che aiuta a veicolare con ulteriore forza scenica i temi civili e sociali che da sempre Davide Sacco e Agata Tomšič pongono a scaturigine del loro colto e al contempo artigianale lavoro: una presa di parola scomoda e radicale, incurante delle mode ma al contempo accorta di ciò che accade nella società, italiana e non solo, teatrale et ultra. «Tutto ciò che vedi e che racchiude l'umano e il divino è un tutt'unico» vien detto sul finire dello spettacolo. Chi ha orecchie per intendere, intenda.
Michele Pascarella
---
Recensione di Celeste. Appunti per natura di Raffaella Giordano, p. 85.
L’intimità estesa di Raffaella Giordano
CELESTE. APPUNTI PER NATURA, solo di Raffaella Giordano. Incipit e musiche per pianoforte Arturo Annecchino. Incontri straordinari, complicità e pensieri Danio Manfredini e Joelle Bouvier. Editing e composizioni astratte Lorenzo Brusci. Luci Luigi Biondi. Costume realizzato da Giovanna Buzzi, dipinto da Gianmaria Sposito. Prod. Associazione Sosta Palmizi (Cortona AR).
Si sviluppano su una linea sottile, in bilico tra cultura e natura, questi Appunti: è una danza lirica e dolente, antica e sapiente, che dà luogo a un ininterrotto piano sequenza, un unico movimento organico che varia direzione, altezza, forma e velocità ma mai si spezza. Alcuni saltelli à la Duncan, a evocare la possibilità del corpo di farsi strumento di libertà, sono preludio a una coreografia morbida, levigata, frutto di un tempo lungo di fioritura e di uno lunghissimo di pratica coreutica. Linee curve e allungamenti, rotazioni e guizzi disegnano diagonali e spirali, cerchi e perimetri: movimenti millimetrici e morbidissimi, in dialogo con una partitura minimale per pianoforte immersa in un impasto sonoro materico, a tratti tellurico. Sideralmente distante da qualsivoglia attitudine dimostrativa, l’arte di Raffaella Giordano pare la condivisione di un'esperienza, di una intimità estesa ai guardanti: non vi è traccia di un io che si impone per esplicita maestria quanto, piuttosto, la manifestazione di una idea e una pratica di arte come allargamento della visione, dell’ascolto, dell’attenzione sottile alle esperienze del corpo-teatro danzante in relazione allo spazio e a ciò che lo abita (altri corpi: fisici, sonori, luminosi). Alcuni fogli bucati evocano volti: è danza di fantasmi, tesa a suggerire piuttosto che a descrivere, a celare piuttosto che a mostrare, a rendere la vita manifesta, percepibile, piuttosto che ritrarla in una rappresentazione. Mille immagini sono accennate e subito dissolte in altre composizioni, a tratteggiare un ipnotico racconto non lineare, un magistrale esercizio di visione.
Michele Pascarella
L’Apocalisse spaziale e sonora di Laminarie
INVETTIVA INOPPORTUNA, regia, ideazione scene, luci e audio Febo Del Zozzo. Drammaturgia Bruna Gambarelli. Testi Matteo Marchesini. Prod. Laminarie (BOLOGNA). Coprod. ERT / Teatro Nazionale.
Febo Del Zozzo prosegue la ricerca materico-performativa di Dentro le cose con un passo ancor più radicale nella costruzione di un teatro inteso come luogo in cui il corpo si fa al contempo oggetto, motore e veicolo di sguardi e visioni. Tuta blu da operaio, passamontagna nero a celare il volto (non vi sono psicologia né interpretazione di personaggi, ma un organismo animale che si offre allo sguardo), Del Zozzo abita e agita uno spazio reso percettivamente tridimensionale da un fitto reticolo di funi azzurre che sonorizza live con un sistema di microfoni applicati agli arti, dando forma a una spigolosa quanto ammaliante partitura di suoni poveri e concreti (come non pensare agli Intonarumori di Luigi Russolo per l’analoga tensione a dare dimensione estetica, dunque conoscitiva, a una materia bassa, finanche fastidiosa): corpo sonoro che si rifrange in e attraverso un corpo materico, luminoso e biologico. Risultato: un corpus performativo misterioso e ammaliante, feroce e poetico. Echi e bordoni, sequenze buio-luce-buio, violente partiture fisiche (salti, colpi a terra, tonfi, rotazioni), frasi ossessivamente reiterate (ancorché con voce progressivamente distorta, a rendere le parole puro suono, grido inintelligibile prima e al di là di ogni significato). Davanti ai nostri occhi accade, letteralmente, un’Apocalisse, dunque, etimologicamente, una catastrofe e una rivelazione: con incontenibile pars denstruens il performer smonta, a vista e in un tempo drammaticamente dilatato, il reticolo di funi, il mondo-labirinto che fino a quel momento è stato gabbia e al contempo nido della figura feroce e dolente che potrebbe essere uscita in quell’istante da un quadro di Francis Bacon. Sul finale, Del Zozzo si libera di costume e microfoni e dice un testo poetico di Matteo Marchesini. Come una resa.
Michele Pascarella
Il Pascoli
pasoliniano di O Thiasos TeatroNatura
ATHENE NOCTUA, dal poemetto La Civetta di Giovanni Pascoli, di e con Sista Bramini e il Trio Viola Contra Kora: Camilla Dell’Agnola (canto e viola), Daniele Ercoli (canto e contrabbasso) Silvia Balossi (canto e kora). Prod. O Thiasos TeatroNatura (ROMA).
«Io sono ciò che di me sfugge agli occhi umani: l’invisibile»: dà voce a Socrate, il poemetto La Civetta di Giovanni Pascoli, e racconta l’approssimarsi della morte del filosofo. In una sporca piazza di Atene alcuni ragazzini stanno tormentando una civetta (uccello sacro alla dea Atena e il cui nome scientifico dà il titolo allo spettacolo). Lì si trova la prigione della città in cui Socrate, detenuto per empietà e corruzione di giovani, sta per bere la cicuta. I giovani fanno confusione, il custode esce per farli tacere. I discepoli di Socrate sono atterriti, lui li rassicura: la sua essenza invisibile è destinata a congiungersi a ciò che è eterno. La vicenda (come non pensare a Pasolini, per l’ambientazione marcatamente popolare intrecciata a precisi rimandi alla classicità) è narrata con solida sapienza da Sista Bramini, in dialogo con un inconsueto ed ammaliante trio (composto da viola, contrabasso e kora, un’arpa africana) a proporre musiche e canzoni di area mediterranea, soprattutto di provenienza greca e grecanica. Oltre all’inusuale scelta di mettere in scena questo prezioso poemetto e alla grande maestria delle interpretazioni, due sono i principali motivi di interesse per questo commovente «concerto-spettacolo». Il primo: presentare un dispositivo spettacolare in cui musiche, canti e narrazione sono paritetici, si compenetrano e completano a vicenda, in cui la musica non è, come troppo spesso è dato a vedere, mero abbellimento o decorazione del testo. Una scelta a suo modo coraggiosa, in un sistema di distribuzione dell’arte dal vivo che spesso si organizza per comparti rigidamente strutturati e separati. Secondo motivo di apprezzamento: Athene noctua dà corpo e voce a una idea e a una pratica di arte rigorosa e lieta che da tre decenni fa dell’ascolto profondo e radicale dei luoghi naturali che abita il punctum della propria azione. Alla ricerca del genius loci: ibridando immanenza e trascendenza, il qui e l’altrove, le forme del mondo e l’ineffabile.
Michele Pascarella
---
Recensione di Touch me e Taste me di Gurshad Shaheman, p. 74.
Il teatro rasico e performativo di Gurshad
Shaheman
TOUCH ME e TASTE ME, ideazione, regia, interpretazione Gurshad Shaheman. Drammaturgia Youness Anzane. Musiche Lucien Gaudion. Cena Amer Ghaddar. Traduzione in italiano Luca Ricci. Prod. Rencontres à l’échelle (F).
Vera sorpresa di Kilowatt 2021 (rispondente a una delle funzioni dei Festival: offrire formati, nomi e modi altri piuttosto che replicare ciò in cui ci si può imbattere nelle consuete Stagioni) l’artista franco-iraniano ha presentato in prima nazionale i primi due capitoli della trilogia Pourama Pourama, creata a partire dal 2012. Fascinoso quanto inclassificabile ibrido di teatro rasico (termine mutuato dalla teoria dei sapori -rasa- del teatro indiano classico) e performativo (nel senso di porre al centro un soggetto che parla e agisce a proprio nome, rivolgendosi al pubblico in tale veste, realizzando una messa in scena e condivisione del proprio io), il dittico è accomunato, formalmente, da un lungo racconto registrato in cui l’autore narra episodi della propria infanzia, del complesso rapporto con il mondo e della scoperta della propria omosessualità con un affondo nel rapporto con il padre (Touch me) e con la madre (Taste me). Una scrittura concreta, finanche visiva, portata alla voce con pacata ferocia su un tappeto sonoro che alterna brani tradizionali persiani, canzoni pop e bordoni elettronici dagli echi metallici. In entrambe le creazioni l’interprete si offre allo sguardo degli spettatori in un comune rituale d’ascolto di quanto la voce fa vedere. Touch me suona come secca invocazione, sia nel racconto del rapporto col padre assente che nell’espediente di uno schermo che annuncia ripetutamente che lo spettacolo si sarebbe interrotto da lì a poco se nessuno avesse stabilito un contatto fisico con il performer, in piedi al centro della scena. Taste me si sviluppa con l’artista en travestie che prepara un piatto tipico iraniano e lo serve agli spettatori seduti a tavola, per poi a sua volta mangiare ascoltando in silenzio la propria voce, in un millimetrico, dolente, seducente reticolo di sguardi. Una (doppia) celebrazione dei sensi mediante la fondante presenza dell’artista, al contempo oggetto e soggetto di una creazione tanto indefinibile quanto folgorante.
---
Recensione di Pastorale di Daniele Ninarello, p. 75.
L’Espressionismo Astratto di
Daniele Ninarello
PASTORALE, ideazione e coreografia Daniele Ninarello. Con Vera Borghini, Zoé Bernbéu, Lorenzo Covello, Francesca Dibiase. Dramaturg Gaia Clotilde Chernetich. Musiche Dan Kinzelman. Movement coach Elena Giannotti. Costumi Ettore Lombardi. Luci Gianni Staropoli. Prod. Codeduomo / Compagnia Daniele Ninarello (TORINO), coprod. Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape (F).
Un grande rettangolo
di luce dorata, sulla parte alta del fondale, illumina la scena. Vien da
pensare a Mark Rothko, certo. E all’Espressionismo Astratto,
immersi nella magnetica creazione del talentuoso coreografo torinese, che con
mano ferma guida quattro dediti interpreti in un territorio ibrido, inizialmente
più performativo che coreutico. Come nel movimento che ebbe fra i principali
esponenti Jackson Pollock, anche in questo spettacolo quel che richiede e dà
identità è il gesto artistico, prima e al di là di ogni narrazione o illustrazione:
Pastorale realizza una sorta di «action dancing», si potrebbe azzardare
parafrasando il celebre pittore americano, che pone al centro del fatto scenico
corpi in relazione cinetica significante con altri corpi (biologici, luminosi,
sonori). Fiducia fenomenologica: la presentazione ha qui la meglio sulla
rappresentazione. Quattro monadi stanno in un grande spazio vuoto, in piedi,
con piccoli passi e rotazioni vi rimbalzano: come sospinte dal denso flusso
sonoro e luminoso, come prive di volontà propria, certo sideralmente distanti
da qualsivoglia idea romantica di espressione. In tal senso pare appropriata la
scelta di interpreti dalle caratteristiche sceniche non eccessivamente marcate:
quale disponibilità e sapienza richiede, il divenire trasparenti! Progressivamente,
dal sommesso brulichio iniziale affiorano -e subito scompaiono- atomi di
movimento in sincrono, frammenti di coreografia, lacerti di più esplicito
dinamismo, fino al reciproco e insistito chiamarsi per nome: un’articolazione
dinamica millimetrica che solo una sapiente scrittura coreografica e ritmica può
rendere organica, vispa, attraente. Come nell’Espressionismo Astratto, Pastorale
si fonda su un’autorialità più sensuale che sentimentale, più sensoriale che psicologica.
Bellissimo.
Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi, tra
bandiere e figure
ARA! ARA!, di e con Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi. Suono e composizione Demetrio Castellani. Rullante, percussioni, registrazione Michele Scotti. Coach di sbandieramento Carlo Lobina. Prod. Ginevra Panzetti / Enrico Ticconi (TORINO, BERLINO), Associazione Culturale VAN (BOLOGNA) con il contributo di Hauptstadtkulturfonds (BERLINO).
È
lunga la lista di autorevoli realtà internazionali a diverso titolo coinvolte
nella nuova produzione di
un duo che, in un panorama spesso abitato da epigoni, si caratterizza per cifra
coreutica propria, affatto riconoscibile. La danza minimale e rigorosissima di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi (il
quale sorprende per la qualità quasi animalesca del proprio abitare la scena,
che un dispositivo a tratti un po’ algido per contrapposizione esalta
enormemente) affronta alcuni macro-temi: l’uso linguistico dei simboli, il
rapporto fra tradizione ed esotismo e la costruzione dell’immaginario (dunque dell’idea
di bellezza). Come già in precedenti creazioni (su tutte Harleking, che
trasduceva la figura di Arlecchino) il duo rilegge un elemento dell’immaginario
popolare per proporre un evocativo discorso attraverso una scrittura
coreografica millimetrica: suono di rullanti e sventolare di bandiere danno
forma a figure epiche e fantastiche tra bestiari medioevali e scene di
battaglia, passaggi al rallentatore e tableaux vivants,
composizioni geometriche e frammenti espressivi (come non pensare alla danza
con le stoffe di Loïe Fuller). Il riferimento al pappagallo Ara, icona
di esotismo e bellezza, propone una possibile indicazione di sguardo: ricevere
le forme in movimento in quanto tali, puro appagamento sensoriale prima e al di
là di ogni giudizio o possibile lettura. Quanto di più distante dall’attitudine
che caratterizza noi guardanti occidentali?
Michele Pascarella
---
Recensione de Il mondo altrove di Nicola Galli, p. 76.
Nicola Galli e la fascinazione per l’alterità
Un
solo esempio, ma celebre: la scoperta fatale del teatro-danza balinese da parte
di Artaud all’Esposizione Coloniale di Parigi nel 1931. Da molto tempo il teatro
e la danza occidentali attingono forme e intenzioni -anche per un bisogno di
rinnovamento profondo dell’arte scenica- dai teatri orientali. Il giovane ma
già affermato coreografo e interprete Nicola Galli ripercorre, con il rigore e
la pulizia che gli sono propri, un analogo attraversamento transculturale,
aprendo il proprio universo creativo a modi e simbologie provenienti dall’altra
parte del mondo. Il risultato è una creazione evocativa, a tratti finanche
narrativa, in cui Galli funge da officiante di un rituale minimale e rarefatto,
agito in uno spazio geometrico con campiture monocrome: file di pietre,
maschere, posture stilizzate e codici gestuali altri danno corpo a un
immaginario esotico e sacrale, misterico e avvolgente. Il rischio «folcloristico»
è evitato anche grazie a una determinante scelta musicale: il paesaggio
microtonale tratteggiato da Giacinto Scelti costituisce una solida quanto
inaspettata materia sonora a cui la scrittura coreografica si accorda, a
livello tonico e ritmico, creando un unicum inclassificabile e
ammaliante. A Kilowatt Festival la creazione è stata preceduta da una performance
itinerante, di e con Nicola Galli, che ha attraversato le strade del centro
storico e che ha dato modo all’artista di mostrare, intrecciata alla consueta
raffinatezza, un vigore famelico, energico ed energizzante, affatto
sorprendente.
Furore e pietas, nelle Coefore di
Enzo Cosimi
Pars destruens e pars
construens, annichilimento e vitalismo, furore e pietas: è un campo
di forze contrapposte e feroci, la seconda tappa del progetto che il celebre
coreografo ha dedicato all’Orestea. In un paesaggio invaso da peluche
impiccati, giocattoli di plastica e coperte di lana colorata -esplicito omaggio
all’universo creativo dell’artista visivo Mike Kelley e con esso all’idea duchampiana di nutrire
l’esperienza artistica con quella quotidiana- quattro vigorosissimi danzatori e
una fiammante musicista si offrono a una sorta di sabba
decadente, in cui un apparentemente insensato dispendio muscolare, cinetico e
sonoro lascia nei guardanti un retrogusto amaro, finanche struggente. Tuniche
nere, volti celati, partiture ginniche, corse in cerchio, furibonde danze
solitarie, neon colorati, facce dipinte: Cosimi è maestro nella
composizione di un habitat sguaiato e al contempo delicatissimo, per un atto d’amore
verso un manipolo di corpi (fisici, sonori, materici) che si offrono allo
sguardo non più, o non solo, per essere indagati dal punto di vista dei loro
significati, ma come luogo complesso in continua trasformazione. Questo ibrido
di teatro, installazione, concerto e danza traduce gli archetipi eschilei
attraverso figure insensate e gloriose che in un tragico equilibrio di
dinamismo e stasi, reiterazioni e guizzi improvvisi celebrano la possibilità di
una bellezza altra (come non pensare, a tal proposito, alla Venere
degli stracci di Michelangelo Pistoletto?). In Coefore Rock&Roll si
mescolano memorie d’infanzia, rituali satanici e tragiche dinamiche familiari: è
un tuffo in una dimensione in cui Miti e miti (della Storia così come delle biografie
di ciascuno) si mutano in segno, in cicatrice.
Recensione di Enigma del Teatro Valdoca, p. 83.
Teatro Valdoca: un habitat per Pinocchio
ENIGMA. Requiem per Pinocchio. Regia, allestimento e luci Cesare Ronconi. Testo originale Mariangela Gualtieri. Con Chiara Bersani, Silvia Calderoni, Mariangela Gualtieri, Matteo Ramponi e con, al canto, Silvia Curreli, Elena Griggio. Musiche dal vivo di e con Attila Faravelli, Ilaria Lemmo, Enrico Malatesta. Prod. Teatro Valdoca (CESENA), Emilia-Romagna Teatro Fondazione.
Habitat è, in biologia,
l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie di
animali o di piante. In senso figurato, un ambiente congeniale alle proprie
inclinazioni o ai propri gusti. Questa doppia accezione pare appropriata a sintetizzare la
nuova creazione di Teatro Valdoca, ben imponente per numero di persone in scena
(nove, più il regista) e per investimento produttivo (due anni di gestazione,
due lunghe residenze creative). Regia come creazione di condizioni per favorire
relazioni significanti fra i corpi (fisici, sonori, luminosi, materici,
verbali), a dar vita a un oscuro e al contempo luminoso rito teatrale trasformante,
medicamentoso. Lo spettatore è chiamato, grazie a un
sapiente montaggio che giustappone per via alchemica materiali scenici
eterogenei, a dare forma nella propria mente a immagini e immaginari: paesaggi,
bestiari fantastici e figure collodiane (Pinocchio-Calderoni, Fatina-Bersani,
Mangiafuoco-Ramponi) sono suggeriti più che descritti o interpretati, in un
habitat reso denso da un reticolo sonoro percussivo, elettronico e vocale
(straordinario il canto di Curreli e Griggio, che con minimali interventi e
variazioni mutano, letteralmente, la percezione). Enigma è stato da noi incontrato in un
teatro all’italiana: spettatori sui palchi e azione tra platea e palcoscenico.
Tale prossemica, unita a una coreografia (nel senso di scrittura di corpi nello
spazio) quasi mai frontale, ha efficacemente trasdotto la veemenza esortativa
che da sempre connota i versi di Gualtieri: come in una sorta di teatro
anatomico ed esoterico, lo spettatore è reso testimone di un’opera dell’arte
che pone al centro l’effetto della propria azione mediante le
proprie forme (come non pensare al Teatro delle Orge
e dei Misteri di Hermann Nitsch o a certe azioni processuali di
Joseph Beuys). A tal proposito, emerge una
domanda aperta: se è vero che la storia dell’arte è (anche e soprattutto)
storia del come, la seconda accezione di habitat evocata in queste righe
si realizza in stilemi e temi affatto consueti per la storica Compagnia
cesenate. Di quale enigma si tratta, qui?
Michele Pascarella
Parola
poetica, compagna di scena
Elena
Bucci, Mariangela Gualtieri, Ermanna Montanari, Moni Ovadia e Marcello Sambati
raccontano la loro relazione attorale con la poesia, in rapporto alla
solitudine.
di Michele Pascarella
Non c’è differenza fra teatro e poesia: / non c’è teatro di poesia - / c’è la poesia / che è / della poesia nel teatro / il vento»: pare appropriato, Giuliano Scabia, per aprire una ricognizione sul rapporto tra solitudine scenica e parola poetica, con un’attenzione specifica alla possibilità che essa divenga compagna di scena.
«La poesia sospende la tecnica, anche se,
senza tecnica, diventa difficile lasciare trasparire la poesia» riflette Elena Bucci «Bisogna diventare
funamboli di voce, di suono, di movimento, di memoria, niente altro e niente di
meno, ma anche niente di più. Ogni volta è una sorpresa e un mistero, ogni
volta devo imparare di nuovo a sottrarmi, per lasciare che quel silenzio che
resta alla fine sia davvero nudo, mio e di tutti quelli che vogliono e che
passano da lì. Come ci si sente fratelli e bambini se riesce questo fragile
miracolo, tutto umano, come se si venisse dalla stessa casa, dallo stesso
cortile e si potesse dire “ti ricordi?” senza paura di non essere riconosciuti».
Spiega Mariangela Gualtieri: «Mio intento è cadere nell’atto contemplativo della scrittura e ricreare il tempo sospeso della precipitazione poetica. La concentrazione è tale da rendere la mia solitudine vertiginosa. Sto camminando su un filo acustico teso ad alta quota e non ho tempo per altro che non sia l’esattezza millimetrica di ogni passo: basta un respiro sbagliato per rompere l’incanto fonico. Sì, sono sola, nessuno può soccorrermi, ma innumerevoli fili sono tesi fra me e chi è in ascolto, e la loro immobilità, il loro silenzio, è la più alta forma di partecipazione che io abbia mai sperimentato a teatro. Siamo insieme in un viaggio cosmico, seppure ognuno è con se stesso, inabissato nelle proprie profondità».
«Per me un artista non è mai solo in scena» aggiunge Ermanna Montanari «Non si è mai soli, soprattutto se si è così spudorati da entrare in un palcoscenico, già abitato da strati di voci, orme di corpi, occhi che guardano. Si va lì per darsi a vedere, a udire, come si può essere soli? E per quel che riguarda la tecnica, ogni volta ricomincio da capo, ogni volta con grande vergogna, ogni volta nel silenzio del corpo per far emergere il ritmo del verso. E i versi mirabili della Divina Commedia hanno un’esigenza del tutto diversa dai versi dialettali di Nevio Spadoni, dalle drammaturgie di Marco Martinelli. Mi verrebbe da dire che l’ascolto e l’obbedienza alla parola sono una radice tecnica, ma poi la tecnica cade, si inabissa per lasciare spazio all’aria, al respiro, alla musicalità del testo che ci sta di fronte. Se qualcosa di bello succede tra i versi e l’attore che li legge, allora sì, è il coro del teatro, la radice che da essi si genera».
Moni Ovadia racconta: «L’esperienza più pregnante
con un testo poetico è avvenuta con i poemi di Ghiannis
Ritsos: un compagno d’armi, uno che ti salva la vita con le parole. Altro incontro fondante fu con Il canto del popolo ebraico massacrato di Itzhak Katzenelson: in
forma scenica ho tenuto sia la lingua originale che la traduzione italiana,
utilizzando un recitar cantando
che mettesse in evidenza la dimensione musicale di quelle parole. Il poeta ha
una strategia sonora che io porto al dire lasciandomi andare all’integrità del
fare poetico. Mai sovrapporsi al poeta: bisogna esserne al servizio, non farne
un materiale. La solitudine è la condizione ideale per fare, dire e cantare
poesia in teatro. Ma in realtà non si è soli: si è in scena con il poeta».
«La poesia non si recita, si assume»
conclude Marcello Sambati «Chi la
dice, chi la mette in scena, deve avventurarsi nelle deformazioni del proprio
corpo, a modellarlo e piegarlo per farsi visione e ritmo, fragilità e potenza,
spazio e drammaturgia in atto, fenomeno e forma inafferrabile. È poetica
l'opera che travolge l'autore, che lo isola nell'abisso di un tempo immobile di
oscurità e folgorazioni accecanti. Dialogo tra voce e silenzio, fino allo spasimo, al punto cieco
della lingua, sul suo limite, dove ogni parola sarà come un seme salvato dalla
tenebra, e perciò occorrerà prendersi cura del difetto, dell'errore, della
fragilità della parola umana. La poesia non può essere rappresentata, la
poesia si presenta, si mostra come apertura, apre alla creaturalità
dell'essere nel mondo, pura relazione dell'essere con la natura e il mondo».
Una pluralità di modi-mondi rigorosi e luminosi che da decenni -e chissà per quanto tempo ancora- nutrono la scena contemporanea e gli uomini e le donne che, soli e insieme, la frequentano.
---
Recensione di Weiss Weiss del Teatro della Contraddizione, p. 63.
Danza di fantasmi con
Robert Walser
La classe morta di Tadeusz Kantor e May B di Maguy Marin: questi capisaldi del teatro e della danza del secondo Novecento paiono orientare, per temi e stilemi, l’allestimento che il Teatro della Contraddizione realizza attorno a Robert Walser, a partire dal suo Jakob von Gunten. Un diario. Undici fantasmatiche figure agiscono in uno spazio tridimensionale composto da praticabili e cunicoli da cui affiorano e a cui senza posa ritornano, dando corpo a una drammaturgia che intreccia le crude esperienze vissute dal protagonista all’Istituto Benjamenta con vari frammenti testuali, dell’autore e di altri con cui entrò in relazione: una stratificazione appropriata nel voler restituire il complesso universo poetico e biografico di Walser. Il sistema di segni che lo spettacolo articola attorno all’esile e al contempo solidissima figura del protagonista (incarnato con feroce lirismo da una straordinaria Micaela Brignone) poggia su precisissime partiture fisiche e vocali eseguite dall’ensemble in un claustrofobico spazio scenico sovrastato da una scrittura filmica evocante l’opera che nel 1995 i fratelli Quay dedicarono a Jakob von Gunten. Entrambe tratteggiano un paesaggio visivo teso ad assottigliare la distanza tra percepito e immaginato: Weiss Weiss è luogo di fantasmi, appunto. L’atmosfera che l’intride è quella di un ambiente asfittico, opprimente. Recitazione stilizzata, di sapore espressionista. Altissima cura di ogni dettaglio, compresi luci, trucco e costumi. Per edificare un immaginario -più che per articolare accadimenti- surreale e incubotico, dentro al quale lo spettatore è invitato, o piuttosto portato, a perdersi. Unico, ma non secondario, limite è l’abnorme durata -oltre 2 ore e 30 minuti- con annessa moltiplicazione dei finali. Una scelta registica che grandemente indebolisce una creazione altrimenti meritevole di plauso.
Report Festival Terreni Creativi di Albenga, p. 67.
Terreni Creativi Festival: resistere, con allegria
Michele Pascarella
---
Recensione di Tiresias di Giorgina Pi | Bluemotion, p. 68.
Il mito di Tiresia nel poema di Bluemotion
Michele Pascarella
---
Recensione di Black dick di Alessandro Berti, pp. 68-69.
Tra virilità e cultura, con Alessandro Berti
Ben lungi dall’essere mera trovata con tanto di titolo ad effetto atta a solleticare i pruriti del pubblico, la nuova produzione di Alessandro Berti -rigoroso quanto poliedrico regista, attore e drammaturgo emiliano- si pone come una sorta di conferenza scenica su un tema tanto esplicito quanto peculiare: la storia dell’uso del corpo del maschio nero da parte della società bianca americana. Primo spettacolo della trilogia Bugie Bianche, questa creazione -in bilico tra sociologia, antropologia, storia contemporanea e cultural studies- ibrida la storia del teatro a quella americana, il sistema del cinema pornografico e la musica rap, a proporre un discorso teso a mettere in evidenza gli stereotipi che regolano, spesso in maniera inconsapevole, il nostro guardare. Giacca, pantaloni e camicia, una sedia e un proiettore, qualche pianta: Alessandro Berti con fare da (fin troppo) consumato affabulatore si rivolge, tra il sardonico e l’assertivo, a una platea che certo trova, in questa creazione, il soddisfacimento di tre fra i primari bisogni del fruitore di teatro: pensare, istruirsi ed emozionarsi. Black Dick costituisce una molto ben composta forma di teatro didattico in cui tutti gli elementi (l’eloquio, la prossemica, le immagini, la musica il canto) concorrono a veicolare con massima chiarezza la molteplicità e la complessità delle relazioni e delle influenze che definiscono un modello culturale. Pare appropriato, per questo spettacolo, quel che Ennio Flaiano scrisse nel dicembre ‘63 nella sua rubrica di critica teatrale su L’Europeo: «Tutti infine hanno avuto grandi applausi. Pubblico attentissimo. Com’è confortante accorgersi che non si chiedere al teatro ciò che la vita di tutti i giorni ci dà in abbondanza, sopraffazione del gusto, stupidaggine e pornografia». Perfetto, Flaiano, anche in questo caso.
Recensione di L'incidente è chiuso di Menoventi, p. 70.
Il suicidio di Majakovskij secondo Menoventi
Alla fine (violenta) del celebre cantore della Rivoluzione d’ottobre Vladímir Majakóvskij Menoventi dedica un composito progetto scenico, che di quella vita -e di quella morte- restituisce linguisticamente l’intricata ricchezza. Come consuetudine del duo Battiston-Farina, obiettivo della proposizione scenica non è tanto quello puramente storico-documentaristico quanto l’ingaggiare -mediante un dispositivo scenico che costantemente oscilla tra naturalismo e stilizzazione- una sottile partita a scacchi con l’intelligenza e la percezione dello spettatore. Punto di partenza: l’esposizione di un fatto. In questo caso il suicidio di Majakóvskij, indagato con attitudine poliziesca. In questo incidente paiono affatto efficaci alcuni espedienti messi in atto per raffreddare una materia tanto tragica: dalla figura marziana, narrante e interrogante (Battiston) disumanizzata da numerosi segni fosforescenti alle risate in stereofonia che punteggiano e dileggiano l’accorato discorso di Majakóvskij, da sezioni di testo con smaccate rime baciate a un’esatta partitura di contrappunti sonori sintetici, a rendere sincopato e innaturale lo svolgersi del dramma. In questo allestimento tornato temi e stilemi di precedenti creazioni dell’ensemble, tra cui l’esatta tessitura di repentini quanto spiazzanti scarti temporali e le millimetriche ripetizioni di frammenti testuali e brevi scene, ponendo in evidenza la finzione teatrale. La figura di Consuelo Battiston, ancora una volta in relazione di gelida estraneità-superiorità rispetto ai personaggi in scena, affianca ai caratteri spigolosi già espressi in altri allestimenti nuove sfumature e inedite composizioni plastiche e cinetiche, che a tratti evocano certe figurazioni del celebre Balletto Triadico di Oskar Schlemmer.
Michele Pascarella
---
Recensione di Trent'anni di grano. Autobiografia di un campo del Teatro delle Ariette, p. 70.
Il teatro
amoroso e amorevole delle Ariette
Nuovo tassello di un ininterrotto racconto autobiografico, Trent’anni di grano costituisce un esempio di teatro amoroso e amorevole, rasico e poetico, ad opera di due contadini-attori-sposi che fanno della piena ostensione di sé la propria cifra, incarnando e al contempo comunicando un immaginario bucolico e romantico che il pubblico accoglie con grata semplicità. Vi è sempre il cibo, all’origine degli accadimenti del Teatro delle Ariette, cucinato in scena mentre si narra, legge, canta o racconta e poi offerto ai presenti. Questa Auotobiografia di un campo parla una lingua diretta e sentimentale, atta a costruire con lo spettatore-commensale una relazione calda, accogliente e affatto concreta: come non pensare alle «azioni sincere» invocate da Jacques Coupeau o al lavoro dell’«operaio esperto» proposto da Mejerchol'd come modello? Trent’anni di grano -nomen omen- narra degli ultimi tre decenni di vita e di sperimentazioni sceniche e agricole della Compagnia. Poche decine di persone sono sedute attorno a uno spazio rettangolare ricoperto di chicchi di grano, tra taglieri e mattarelli, farina e piastre per cuocere, grembiali, piatti e cestini di paglia. Si ascoltano pagine di un diario, scritto quotidianamente nell’estate 2019 «per trattenere immagini e il tempo che passa», da cui affiorano fatiche nei campi e sogni di morte, animali domestici e viaggi teatrali, desideri erotici e di pace. Berselli legge commossa, mentre Pasquini e Ferraresi con calma cucinano. In sottofondo, a volume bassissimo, la celeberrima Summertime, in loop. Sugli applausi arriverà Canzone per l’estate di Fabrizio De André. Il tasso di emotività è inversamente proporzionale alla finzione teatrale: si recupera, al contrario, un’accezione etimologica di teatro come luogo dello sguardo (su altrui biografie) e della visione (su altrui immaginari). Uno spettacolo semplice, emotivo e nutriente.
Michele Pascarella
---
Isadora Duncan, secondo Jérôme Bel
Non nuovo alla composizione di ritratti di celebri coreografi e danzatori (basti pensare alle creazioni dedicate negli ultimi vent’anni, tra gli altri, a Xavier Le Roy, Véronique Doisneau, Lutz Förster e Cédric Andrieux), in Isadora Duncan Jérôme Bel attraversa ed espone, con attitudine enciclopedica, la biografia artistica di una delle grandi pioniere delle rivoluzioni coreutiche di inizio Novecento. In scena la matura danzatrice Elisabeth Schwartz (allieva in linea diretta di alcune Isadorables, prima discepole e poi figlie adottive della Duncan) mostra frammenti staccati di diverse creazioni, introdotti con asciutta, didattica chiarezza da una delle assistenti di Jérôme Bel, Chiara Gallerani. La performance si pone, nei contenuti e nei modi, come una sorta di lezione di (storia della) danza, con tanto di coinvolgimento di alcuni spettatori: brevi frasi di movimento sono ripetute, a scopo dimostrativo, con e senza musica e con parole-chiave che la stessa Duncan utilizzava per stimolare, per via descrittiva o simbolica, immagini e immaginari, in un universo poetico fatto di elementi naturali e classicità greca, di piedi nudi e tuniche, di morbidezza e libertà. Delle circa cento coreografie create dalla Duncan, solo una quarantina sono quelle la cui traccia è arrivata a noi tramite fotografie, disegni, sculture e scritti autobiografici: nessun filmato, perché i mezzi dell’epoca non permettevano, a detta dell’artista, di restituirne l’essenziale fluidità. L’impossibilità, la mancanza, il tentativo di circoscrivere un’assenza intridono questa semplice, malinconica, commovente lezione.
---
Ritratto di famiglia con figlio adolescente
È uno spettacolo semplice e bellissimo, Tre di ScenaMadre, giovane ensemble ligure impegnato a realizzare un teatro d’arte di e per tutti: sul palco attori professionisti e non, in platea persone di ogni età, in barba alle consuete distinzioni in vigore nel nostro sistema teatrale. Tre presenta una famiglia con figlio adolescente: un genitore o un ragazzo possono ritrovarvi molto della propria esperienza, tutto il pubblico -sia di neofiti che di appassionati- può godere di uno spettacolo massimamente leggibile, composto ed eseguito con divertimento e rigore, con grazia e pulizia. A differenza di molte proposizioni del panorama contemporaneo, che attingono a forme e modi afferenti ad altre arti e sistemi linguistici, il dispositivo di Tre si costituisce di riferimenti ed elementi pienamente teatrali, con una ridda di invenzioni che trovano nella pratica della scena il proprio ritmo e la propria consistenza. Due giovani attori nel ruolo dei genitori e un giovanissimo, istrionico interprete in quello del figlio: all’iniziale incredulità, dovuta all’apparentemente insufficiente differenza d’età tra questi e quello, segue dopo poco la relativa sospensione, tanto è efficace la dinamica scenica messa in opera. Fatti, temi e climi emergono senza posa, per sovrapposizione, come esito dell’incessante comunicazione -verbale, fisica, spaziale- fra le figure. Dal punto di vista della drammaturgia testuale, le parti più efficaci sono costituite da fitti, sincopati dialoghi la cui vivezza origina in tutta evidenza in un semplice, artigianale allenamento all’ascolto e all’agire scenico. Unici oggetti: qualche sedia, a costruire figure e segnare percorsi, procedendo per via ora narrativa ora simbolica. Un teatro povero e necessario, che fa sorridere e commuovere, pensare e immaginare. E ben sperare. Chapeau.
Michele Pascarella
Hystrio 2.2020:
Sezione La parola agli artisti nel dossier Il teatro ai tempi del Coronavirus, pp. 42-45.
Hystrio 1.2020:
Breve intervista a Francesco Pititto | Lenz Fondazione in dossier Fotografia di scena 2.0, p. 53.
---
Recensione di Sotto lo sguardo delle mosche di Tedacà, p. 65.
Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza. Con Matteo Pecorini, Rosario Terrone
e con la partecipazione di Claudio Ascoli. Musiche originali
Alessio Rinaldi. Prod. Chille de la balanza (FIRENZE)
Hystrio 4.2019:
Recensione di Es sagt mir nichts, das sogenannte Draußen e di Die Hamletmaschine di Maxim Gorki Theater, p. 68.
Hystrio 3.2019:
Curatela di uno Speciale dedicato a Pina Bausch, pp. 17-23, all'interno del quale -oltre a scritti di Leonetta Bentivoglio, Sanro Avanzo e Marinella Guatterini e a una piccola bibliografia- è anche pubblicato il seguente articolo:
Hystrio 2.2019:
Recensione di Penthy surla bande di Teatro i, p. 69.
Hystrio 1.2019:
Dossier Teatro e Periferie > Emilia Romagna + focus Teatro dell'Argine, pp. 42-43
L’(Emilia) Romagna Felix rinasce in periferia
Focus: Teatro dell’Argine
Recensione di Saluti da Brescello del Teatro delle Albe, p. 81.
Hystrio 4.2018:
Recensione di Fole di Michelle Moura, p. 66.
105: INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE
CREATIVELY MALADJUSTED, ideazione
Nana Biluš Abaffy, in collaborazione con Milo Love & Geoffrey Watson.
Performers Nana Biluš Abaffy, Milo Love & Geoffrey Watson. Commissionato da Underbelly Arts Lab and Festival. Con
il supporto di Melbourne Festival of Live Art, Phillip Adams BalletLab /
Temperance Hall, Victorian Government con Creative Victoria, Zagreb Dance
Center.
Nana Biluš Abaffy, artista di
Melbourne nata a Zagabria, ha installato negli uffici dismessi di una ditta di
Santarcangelo di Romagna uno spettacolo dolente e lirico, inusitato e
monolitico. Tre magnetici performer, con
ostentata noncuranza, guidano il pubblico in uno spazio fatiscente occupato da
cataste di cartelline, vecchie sedie e scrivanie ammucchiate, cianfrusaglie e
polvere. Il loro fare si accorda con tale disfacimento, a creare un luogo di
macerie e abbandono di cose e presenze: minimi movimenti coreografici e lacerti
testuali, utilizzati a mo’ di invocazioni e invettive, compongono un paesaggio
di tentativi mancati intriso di silenzi e rumori materici (la consistenza
sonora di una sedia trascinata, di un mobile spostato, di un carrello
sospinto), certo non scevro da un certo compiaciuto estetismo del degrado dal
sapore un po’ retrò. Di tanto in tanto affiorano figurazioni che paiono
assecondare un’idea di bellezza classica: sopra a una catasta di cartelline una
composizione di corpi che ricorda la statuaria antica così come l’esecuzione,
in mezzo ai detriti, di passi e posture riconducibili al più nobile balletto
ottocentesco. Pars destruens vs pars construens, si potrebbe forse
sintetizzare. Come non pensare alla Merzbau creata da Kurt Schwitters
nel 1923, secondo il principio di procedere a un riscatto degli elementi
solitamente da destinare a qualche discarica? Cattedrale delle miserie
erotiche: il titolo integrale della Merzbau potrebbe forse essere applicato anche a 105,
spettacolo in cui la reiterata nudità dei performer (di cui un transessuale) è
presentata senza alcunché di conturbante, finanche con intenzionale sciatteria.
Nessuna luce teatrale, né musica registrata: il mondo così come si presenta è
luogo e motore di questa arte. Che piaccia o meno.
Michele Pascarella
I AM WITHIN, con Gioia Pascucci e con Alma
Pascucci. Coreografia Teodora Castellucci. Musica originale Demetrio
Castellucci. Disegno luci Eugenio Resta. Costumi Guoda Jaruševiciute. Cura
Agata Castellucci. Con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito
dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.
Prod. Societas, CESENA.
Parte, insieme a I
am without, di un dittico che si pone come scandaglio delle profondità
della mente, il nuovo spettacolo di Dewey Dell vede in scena una performer
dodicenne che con sorprendenti precisione e potenza esegue, davanti a un
fondale nero, una partitura coreografica elaborata da Teodora Castellucci. È un
immaginario ben poco “bambinesco” quello a cui si dà corpo, lasciando spazio a
una concezione dell’infanzia come età in cui si è più vicini al lato
misterioso, finanche insondabile, dell’essere e del sentire. La partitura, che
intreccia scattanti passaggi astratti a una ridda di immagini che emergono
anche dalla proteiforme interazione con un lenzuolo bianco, unico oggetto di
scena, ripropone fedelmente la qualità di movimento (energico e flessuoso, muscolare
e lirico) della talentuosa autrice: come non pensare al rapporto di Isadora
Duncan con Les Isadorables, le giovani allieve da lei adottate che, fin dal
nome, divennero suoi epigoni? I am within,
pur inanellando una serie di montée
che sembrano ripetutamente preludere a un finale che tarda ad arrivare, ha il
merito di proporre allo sguardo del fruitore una compresenza, affatto
contemporanea, di presentazione (una ragazzina che non fa la bambina,
semplicemente lo è) e rappresentazione (le molte immagini emergenti mediante la
partitura coreografica). Ciò è amplificato dall’entrata in scena, negli ultimi
minuti, di un’infante più giovane, travestita con abiti regali, le cui minime
azioni ludiche nello spazio, con tanto di piccoli giocattoli, enfatizzano la compresenza
delle suddette modalità comunicative. La scrittura musicale, realizzata su suoni a
bassa frequenza provenienti da cetacei, descrive e al contempo sostiene, con
vigore, il tema del dittico, la cui altra metà ha per protagonista
un’adolescente.
Michele Pascarella
A LETTER TO MY NEPHEW, coreografia Bill T. Jones con Janet Wong e la Compagnia. Scene Bjorn Amelan. Musica originale eseguita dal vivo da Nick Hallett. Luci Robert Wierzel. Costumi Liz Prince. Video Janet Wong. Sound design Samuel Crawford. Interpreti Vinson Fraley Jr., Barrington Hinds, Shane Larson, I-Ling
Liu, Penda N’Diaye, Jenna Riegel, Christina Robson, Carlo Antonio Villanueva e
Huiwang Zhang. Con Matthew
Gamble, baritono.
Prod. Bill
T. Jones / Arnie Zane Company, NEW YORK.
Una
ridda di cliché costituisce (e affligge)
la nuova produzione del celebrato coreografo americano, qui intento a creare
una «cartolina» dedicata al nipote, promettente artista e modello finito tra
droga, prostituzione e malattia. Presentato in prima nazionale al Ravenna
Festival, secondo le intenzioni di Jones lo spettacolo si propone come
creazione site-specific tesa a dialogare
con le istanze sociali e politiche di ogni città in cui viene presentato: nel
caso romagnolo ciò si risolve in alcune proiezioni di immagini di mosaici e
poco altro. Banalità da cartolina, appunto. Medesimo trattamento è destinato
alla ricostruzione, per brevi quadri, degli ambienti di vita del giovane
dedicatario: le sfilate di moda, la vita di strada, il letto di ospedale. Tutto
è rappresentato con triti stilemi: felpe e risse simulate, musica da strada e
penombre da bassofondo. In questa sorta di ballet d'action contemporaneo l’anelito narrativo ha la meglio sull’indubbia perizia
di Jones nella composizione dei quadri, nella disposizione dei corpi nello
spazio e nell’articolazione di pieni e vuoti della scrittura complessiva.
Peccato. In quanto a sapere coreografico Jones è certo un maestro e l’ensemble
dei danzatori ha la grazia di una nitida, finanche adamantina precisione nel movimento
(evidente soprattutto nei sincroni e nella segmentazione dinamica di busti e
arti superiori): ciò sarebbe bastante a creare un sistema significante e autosufficiente.
A conclusione dei settanta minuti abbondanti di spettacolo è posto un
video-discorso al nipote, intriso di una quantità di luoghi comuni tra
ottimismo della volontà e retorica (tutta americana) da self-made man, per di
più nero e omosessuale. Presenza della parola, attenzione al gesto quotidiano,
utilizzo di oggetti di uso comune, fusione di istanze personali e temi
collettivi, abbandono di forme predefinite, centralità del corpo: se ciò
quaranta e più anni or sono, quando Jones iniziò a creare coreografie, costituì
un segno altro rispetto al panorama
coevo, dunque con indubbio valore di primogenitura (che l’establishment
coreutico internazionale gli ha peraltro pienamente riconosciuto), questo
recente esito performativo ha tutto il sapore, per mancanza di una pregnante
trasduzione linguistica del tema prescelto, di un passo falso.
Michele Pascarella
Hystrio 3.2018:
Hystrio 2.2018:
Recensione di Iperscene 3 a cura di Matteo Antonaci e Sergio Lo Gatto, p. 73.
Hystrio 1.2018:
Sembra un omaggio a Leo de
Berardinis il nuovo, bellissimo spettacolo del Teatro dell’Argine. Del grande
uomo-teatro campano, innanzi tutto, nel testo risuona un’analoga sensibilità politica,
nel senso che concerne la polis: non
è certo un caso che il gruppo di stanza a pochi chilometri da Bologna nei mesi
scorsi sia balzato agli onori delle cronache teatrali per Futuri Maestri, visionario progetto che ha coinvolto centinaia di
giovanissimi cittadini. Di quell’utopica esperienza, a suo modo figlia della non-scuola del Teatro delle Albe, in Casa del Popolo risuona l’identica
ricerca di un teatro che, come per Leo, sia (ri)costruttore di comunità. Le
parole di Nicola Bonazzi chiedono di essere lette a voce alta, in tutta
evidenza scritte avendo ben presente il pubblico a cui si rivolgono: come non
pensare all’idea, più volte espressa da de Berardinis, di teatro come «tecnica
conoscitiva dell’incontro» tra attore e spettatore? Di attori in Casa del Popolo ce ne sono tre, a dar
voce e corpo a un copione che con magistrale sensibilità ritmica intreccia
didascalie e discorsi diretti, cadenze vernacolari e raffinatezze linguistiche,
Brecht e Piero Manzoni. I tre comprimari lasciano affiorare, con solida sapienza
artigianale, una ridda di tipi:
comici e malinconici, evanescenti e terrigni, peculiari e archetipici, che una regia misurata
intreccia con precisa chiarezza. Abitano una scena che per stilemi evoca
pienamente il teatro dialettale emiliano romagnolo: un tavolo, tre sedie e una
porta di legno sul fondo. Null’altro. Come non ricordare il Teatro Popolare di
Ricerca evocato da de Berardinis? O, ancora, certi caratteri incarnati dal
corregionale Luigi Dadina? La parabola tracciata nei cento anni nei quali la
vicenda si svolge (da un secolo fa ad oggi è l’arco temporale in cui la nostra
società è trasdotta, qui), declina verso un progressivo abbruttimento: un noi che diventa io. Su tutto «una nostalgia per una vita altra, da rivendicare poi nel quotidiano». Come direbbe Leo.
Hystrio 4.2017:
Recensione di Two Playful Pink di Yasmeen Godder, pp. 61-62.
 |
| The Olympic Games - foto di Luca Del Pia |
Le
due nuove proposizioni performative di Chiara Bersani recuperano e incarnano un
senso «etimologico» del teatro, inteso come luogo dello sguardo e della visione:
entrambe, pur nella diversità dei meccanismi di coinvolgimento dello
spettatore, si (pro)pongono come esperienza nella quale, per dirla con Hans-Thies
Lehmann, «l’aspetto dominante diventa
il face to face, la situazione in atto». Ciò è particolarmente evidente,
e rischioso, in Goodnight, peeping Tom,
accadimento costituito «unicamente» da un gioco di
sguardi e seduzioni silenziose fra le quattro persone in scena e i cinque spettatori: meccanismo relazionale che,
se condiviso, può accendere immaginari proteiformi, ma che rischia altresì di
risultare posticcio, portando a emersione il carattere finzionale di una
relazione che, all’opposto, si vorrebbe «performativamente» autentica: «I
Latini dissero persona» ricorda e
sintetizza il Vocabolario «la maschera di legno portata sempre sulla scena
dagli attori nei teatri dell’antica Grecia, nella quale i tratti del viso erano
esagerati perché meglio potessero essere rilevati dagli spettatori». Rinunciando
a qualunque elemento riconoscibile (testo, coreografia, fabula, musiche, luci, costumi) Goodnight, peeping Tom è un
esempio di «teatro senza spettacolo» in cui
gli artisti in scena, lungi dal proporsi come «oggetto
di ammirazione», funzionano da attivatori di un percorso estetico, finanche
erotico, che ha origini antiche: come non pensare, ad
esempio, alla performance Imponderabilia
realizzata da Marina Abramović e Ulay nel 1977? Non c’è nudità, in Goodnight, peeping
Tom, ma l’esperienza vissuta può essere altrettanto perturbante. Istituisce
una prossemica più convenzionale The Olympic Games,
spettacolo colorato e dolente creato insieme a Marco D’Agostin che pazientemente compone i silenzi,
le immobilità, la postura dei quattro corpi in scena e le minime sequenze
performative nello spazio vuoto: il lento incedere di Bersani su un colorato tapis
roulant
tra sudore, sguardi dritti e sorrisi prepara il terreno alla danza di Ciappina,
che progressivamente emerge tra fiotti e sbruffi, slanci, inarcamenti e
sussulti; il semplice stare (a braccia tese verso l’alto) di
D’Agostin introduce quello (sfibrato, madido) di Ramponi. Minuscole avventure
dello sguardo, che lo sguardo (quello incrociato dei performer, quello del
pubblico) feconda e fa esistere: realtà affatto fisiche che, se recepite come
“segni”, producono senso senza essere concettualmente definibili.
La quinta edizione del Festival
I Teatri del Sacro ha accolto e sostenuto il debutto del nuovo spettacolo di
Alessandro Berti: un contesto pienamente consustanziale a un’opera che tratta
di spiritualità, etica e religioni con sguardo largo e un’attitudine alla
pluralità fenomenologicamente salutare. Lo spettacolo è meritevole di
attenzione per almeno due motivi. Il primo. Dando corpo e voce a un’idea
propriamente «omerica», Leila della
tempesta identifica la bellezza con lo «splendore del sensibile», con la
rappresentazione di un frammento di mondo reale e luminoso: la storia è tratta
da un libro di Ignazio De Francesco, frutto di molti anni di lavoro -tuttora in
corso- di un visionario monaco dossettiano al carcere di Bologna coi detenuti arabi,
a intrecciare Islam e Cristianesimo, Costituzioni democratiche e Primavere
arabe. Il testo (riscritto da Berti) narra un’esperienza ammirevole e
commovente: una sorta di rinnovata «Via della Seta» atta a favorire concreti e
sempre più necessari scambi di cultura fra umani. Il punto di vista proposto
(chi sono le vittime? chi i carnefici?) varia in continuazione, ponendo lo
spettatore in una condizione di salutare spaesamento. Secondo motivo di interesse.
La precisa maestria dei due interpreti e del disegno registico. In uno spazio
minimale (un tavolo, due sedie, pochissime luci pressoché immobili), Alessandro
Berti e Sara Cianfriglia sono figure esatte e complementari: Leila la detenuta,
l’Altro l’assistente spirituale; Leila un fiume in piena di parole e accalorata
espressione, l’Altro in ascolto sottile; Leila indurita, l’Altro incoraggiante.
I due sfaccettati personaggi sono intessuti di pause e controtempi, variazioni
di posture e micro-azioni. Parallelamente la regia (dello stesso Berti) articola
una magistrale alternanza di vuoti e pieni, moto e quiete, parola e silenzio,
estroflessione e ripiegamento introspettivo. Leila della tempesta è un minuscolo, appartato, semplice,
consolante capolavoro. Dire grazie, almeno.
Dadaselfie, nonostante il titolo scanzonato dal sapore vagamente
pop, è uno spettacolo di complessa concezione, nuova emersione performativa di
un pluriennale percorso che intreccia efficace teatro sociale e rigorosa
ricerca linguistica. In scena un’umanità traballante e traboccante (di segni e
di voci, di bisogni e allegria): undici giovani attori con Sindrome di Down con
i quali la Compagnia lavora continuativamente da un decennio. Non si pensi a un
semplice, seppur encomiabile, esito di laboratorio: i due registi allestiscono
un lavoro che, attraverso il montaggio di scene giustapposte più per sensibilità
ritmica che per intento narrativo o didattico scivola senza posa, come una
biglia posta su un piano basculante, dall’ingenuo intrattenimento al più crudo immaginario,
dall’assennato allo sfrenato, dal prevedibile all’inaudito, dall’espressivo
all’espressionista. Parrucche e magliette colorate, alcuni testi detti al
microfono, composizioni dinamiche di corpi nello spazio vuoto: lo stile ricorda
certe proposizioni di gusto nord europeo (come non pensare a Disabled
Theater
di Jérôme Bel & Theater Hora?), con il correttivo di
un calore mediterraneo, nella qualità delle relazioni artistiche instaurate, che
traspare da ogni gesto, figurazione, parola. Dadaselfie è frutto di un’attitudine felicemente maieutica
e spigolosamente libertaria: fa affiorare a fiotti il tema complesso,
potenzialmente rischioso, delle pulsioni erotiche delle persone disabili. Lo fa
con gli strumenti, la grazia e la capacità simbolica del medium teatrale:
memorabile l’evocazione della celeberrima scena di The Power of
Theatrical Madness di Jan
Fabre nella quale due ragazzi, nudi e coronati, eseguono un sensuale ballo di
coppia. Su tutto, salvifica, la gioiosa follia di marca dadaista che lo
spettacolo altresì omaggia fin dal titolo: un fare che vale per se stesso,
senza messaggi o insegnamenti da veicolare se non quelli testimoniati dal
(semplice, coraggioso) fatto di esistere. E di resistere.
Hystrio 3.2017:
Recensione di Muoio come un paese di Francesca Ballico, pp. 79-80.
---
Recensione di Giuramenti di Teatro Valdoca, p. 80.
---
Recensione di Sleep Technique di Dewey Dell, p. 97.
SLEEP TECHNIQUE, ideazione Dewey Dell -
Agata, Demetrio e Teodora Castellucci, Eugenio Resta. Con Agata e Teodora
Castellucci, Ivan Björn Ekemark, Enrico Ticconi. Coreografia Teodora
Castellucci. Musica originale Demetrio Castellucci, Massimo Pupillo. Scena e
luci Eugenio Resta. Voce Attila Csihar. Costumi Guoda Jaruševiciute. Con il
contributo dell'archeologa Dominique Baffier. Prod. Dewey Dell, BERLINO.
Hystrio 2.2017:
Recensione di L'arte e la maniera di affrontare il proprio capo per chiedergli un aumento di Muta Imago, p. 71.
---
Recensione di LUS del Teatro delle Albe, p. 72.
---
Recensione di Verso la specie di Claudia Castellucci / Socìetas, p. 89.
---
Exit, p. 89.
Hystrio 1.2017:
Recensione di Senza titolo per uno sconosciuto di gruppo nanou, p. 93.
Hystrio 4.2016:
Hystrio 3.2016:
Recensione di Hearing di Amir Reza Koohestani, pp. 66-67:
Hystrio 2.2016:
---
Recensione di Con tanto amore, Mario di Paola Tintinelli, p. 70:
CREDI AI TUOI OCCHI, di Gianni Farina. Da un’idea di Consuelo
Battiston e Gianni Farina (Menoventi). Regia Gianni Farina.
Con Consuelo Battiston e Federica Garavaglia, Zoe Pernici, Sofia Taglioni.
Scene Alessandro Panzavolta. Luci Alessandro Panzavolta e Gianni
Farina. Costumi Giovanni De Pol (Dead Meat). Progetto sonoro Mirto
Baliani. Trucco e acconciature Luca Pompozzi. Preparatore
atletico Sonia Brunelli. Assistente alla regia Neera Pieri. Prod.
Emilia Romagna Teatro Fondazione (MODENA)
Il nuovo progetto di Gianni Farina e Consuelo Battiston, anime di
Menoventi in questa occasione scritturati da ERT Fondazione, intende tradurre
in forma scenica il ritratto che Otto Dix fece nel 1925 ad Anita Berber. In
esso il contestato esponente della Nuova Oggettività rappresentò come donna di
mezza età l’allora ventiseienne ballerina, modella e attrice tedesca. È questo
straniamento à la Dorian Gray il punto
di partenza dello spettacolo, nel quale un’energica Consuelo Battiston con fare
da predicatoria maîtresse redarguisce e incita senza posa tre giovani attrici e il pubblico.
La drammaturgia testuale, composta per giustapposizione di brevi frasi, dà voce
a una quantità di luoghi comuni sui temi della donna, dell’età, della bellezza:
è esemplare, in questo senso, il lungo elenco di aggettivi-cliché “al
femminile” letti da Battiston mentre le tre ammiccanti comprimarie sono
impegnate in un ballo dal sapore smaccatamente televisivo. La danza in scena costituisce
una nuova direzione, potenzialmente feconda, nel percorso creativo del gruppo. La longilinea,
gommosa protagonista intreccia il testo con una coreografia stilizzata e
flessuosa, a rendere il proprio corpo al contempo soggetto e oggetto del dramma
presentato. Sul finire del lavoro tre
giovani streghe e Battiston-Berber (deprivata di parrucca e gioielli dopo che la
perdita di una scarpa ha dato avvio al declino) reiterano danzando in cerchio il
«Fair is
foul, and foul is fair» di shakespeariana memoria. Credi ai tuoi occhi, nel dare volume all’opera del pittore tedesco,
fa risuonare per affinità tematica il lavoro della co-fondatrice, assieme allo
stesso Dix e ad altri, del movimento dadaista berlinese, Hannah Höch, i cui corrisivi fotomontaggi
attingono a figure femminili “da rotocalco” per creare perturbanti donne-mostro.
Una protesta contro la stereotipia, forse non solo maschile, di una femminilità
piatta, univoca e servizievole. Quella che Credi
ai tuoi occhi invita, impassibile e feroce, a guardare.
---
Recensione di Edipo Re di Archivio Zeta, p. 76:
Michele Pascarella
Hystrio 1.2016:
Recensione di Macbeth di Verdi / Wilson, p. 92:
---
Recensione di Gola. In tre movimenti di Chiara Guidi | Socìetas Raffaello Sanzio, p. 78:
Michele Pascarella
---
Recensione di La prima, la migliore di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, pp. 76-77:
---
Recensione di Lavoravo all'Omsa del Teatro Due Mondi, p. 75:
---
Recensione di Pinter. Atti Unici di Nanni Garella, p. 74:
Hystrio 4.2015:
---
Recensione di Il volo - La ballata dei picchettini del Teatro delle Albe, p. 68:
---
Recensione di Morte di Zarathustra di Teatro Akropolis, p. 62:
Hystrio 3.2015:
Recensione di Sante di Scena di Teatro delle Moire, p. 85:
Recensione di senza volontà di cattura, francesco di Roberto Corradino, pp. 84-85:
---
Recensione di Boxe - Attorno al quadrato di Civilleri / Lo Sicco, pp. 81-82:
Hystrio 2.2015:
Recensione di FAR di Wayne McGregor, p. 112:
---
Recensione di Preludio e La sagra della primavera di Virgilio Sieni, p. 112:
Virgilio Sieni, fra archeologia e Avanguardia
Recensione di Voci di tenebra azzurra del Teatro Valdoca, p. 95:
Hystrio 4.2014:
Recensione di Jackie e le altre di Andrea Adriatico, p. 85:
Recensione di Col tempo e Esercizi di primavera di Virgilio Sieni, p. 85:
Recensione di BoleroEffect e NO TENGO DINERO di Cristina Rizzo, p. 78:
---
Recensione di Robinson di mk, p. 78:
---
Recensione di Souls di Olivier Dubois, p. 75:
SOULS, creazione e coreografia di Olivier Dubois. Con Tshireletso Stephen Molambo, Youness Aboulakoul, Jean-Paul Maurice Noël Mehansio, Hardo Papa Salif Ka, Ahmed El Gendy, Djino Alolo Sabin. Assistente alla creazione: Cyril Accorsi. Musiche di François Caffenne. Luci di Patrick Riou. Costruzione scene: Robert Pereira. Prod.Compagnie Olivier Dubois, ROUBAIX.
---
Recensione di Proscenium works 1979-2011 di Trisha Brown, p. 75:
PROSCENIUM WORKS 1979-2011, quattro coreografie di Trisha Brown. Con Neal Beasley, Cecily Campbell, Olsi Gjeci, Tara Lorenzen, Megan Madorin, Tamara Riewe, Jamie Scott, Stuart Shugg, Nicholas Strafaccia. Prod. Trisha Brown Dance Company, NEW YORK.
L’occasione è di quelle da togliere il fiato: il glorioso
Ravenna Festival ospita in esclusiva per l’Italia il Farewell Tour della Trisha Brown Dance Company, giro d’addio internazionale
intrapreso nel 2013 a seguito dei gravi problemi di salute della settantottenne
artista statunitense, ultima possibilità di vedere quattro coreografie
elaborate per il palcoscenico tradizionale da Trisha
Brown nel corso di trent’anni.
Si comincia con For
M.G.: The Movie, pièce del 1991 dedicata a Michel Guy, l’illuminato Ministro
della Cultura francese che nel 1972 creò il Festival d’Automne. È il primo
tassello del ciclo Back to Zero, realizzato
per indagare il movimento inconscio: nove interpeti in calzamaglia rosso e
arancio abitano un ambiente ipnotico, minimale, matematico e astratto, che
interagisce con le musiche composte e suonate al pianoforte da Alvin Curran.
L’esecuzione musicale live accompagna anche la seconda
coreografia in programma, Rogues del
2011: un duetto maschile in cui, a turno, i due interpeti interrompono e
proseguono l’uno il movimento dell’altro, a creare frasi coreografiche semplici
e insieme rigorose, esemplificative dello stratificato e ritmico pensiero coreografico
di Trisha Brown.
Dopo un breve intervallo è la volta di Les Yeux et l’âme, brano del 2011 su estratti del Pygmalion di Jean Philippe Rameau. Sono quindici
minuti gioiosi e maestosi, danzati da eleganti ballerini in costumi di stoffa
leggera grigia e azzurra. Questa pièce, forse grazie a sonorità piuttosto intelligibili
e a un vocabolario di movimento facilmente riconducibile all’area semantica
“danza”, è di gran lunga la più esplicitamente apprezzata dal pubblico in sala.
Ha la forza cupa e labirintica di un intricato enigma la
coreografia con la quale si chiude la serata: Son of Gone Fishin’, qui proposta nella early version del 1981. Si tratta di una pièce che la capofila
della post-modern dance ha definito
«l’apogeo di complessità» del suo lavoro. In essa, sei danzatori in costumi
dorati eseguono una complicatissima partitura costituita da flussi e riflussi
che, sebbene sia fissata in ogni minimo dettaglio, dà l’impressione di un
movimento libero, se non addirittura casuale. Gli interpreti danno prova di
memoria e capacità di coordinazione strabilianti, e creano con geometrica
morbidezza un insieme fluido e al contempo claustrofobico.
I quattro lavori proposti incarnano uno dei topoi di questa grande maestra di ingegneria coreutica: «Attraverso
le limitazioni si raggiunge la libertà».
Hystrio 3.2014:
A p. 45, nel Dossier Teatro e performance
Romeo Castellucci: «attori, non performers»
In occasione della personale e la volpe disse al corvo, che Bologna gli ha dedicato tra gennaio e maggio, una conversazione con il fondatore della Socìetas Raffaello Sanzio. Attorno a ciò che muta e a ciò che resta.
Sì, nella misura in cui rimane una tensione sottocutanea, non rivelata. Ha molto senso, perché indica un conflitto che necessariamente si ha con ogni immagine, ad ogni livello: sia come artista che come spettatore. Ogni rapporto con l’immagine è fondato su una mancanza, e sull’assenza di ogni referente. L’iconoclastia presume una battaglia, forse oggi per me in parte conclusa, ma che rimane come spinta di una forza del passato.
e la volpe disse al corvo rispecchia una sua grande attenzione alla linguistica. Cosa la affascina, di questo mondo?
La linea generale del progetto è un’idea della curatrice Piersandra Di Matteo, che ha suggerito come, in molti lavori della Socìetas Raffaello Sanzio, le immagini siano espressioni linguistiche. Tutto ciò che si vede, si prova e si sente in teatro è di natura linguistica: esso riflette sempre se stesso come rappresentazione-in-quanto-tale. A Bologna sono raccolti spettacoli, in parte del passato e in parte nuovi, accomunati da un’idea di linguaggio come veleno, come elemento estraneo, non come qualcosa che unifica. Il linguaggio può essere un’arma mortale.
Considera le figure che abitano i suoi lavori attori o performer? Qual è la differenza, dal suo punto di vista?
Senza dubbio attori. L’attore assume su di sé un personaggio, un demone, mentre il performer mette in scena la propria persona come ontologia. Il teatro accende dei fantasmi che appartengono a un’altra epoca, a un altro luogo. L’attore viene cavalcato da presenze diverse, non c’è, compie un sostanziale atto di assenza. Il performer, al contrario, compie una affermazione autobiografica che trovo meno interessante, perché stereotipata.
Qual è il suo spettatore ideale?
Il problema è la cultura come filtro, come barriera. La condizione migliore trovo che sia l’abbandono. È ciò che cerco di fare anch’io quando vedo uno spettacolo, ascolto una musica o leggo un libro.
Da molti è considerato un maestro. In cosa è stato frainteso?
---
Recensione di The Decision di Masque Teatro, p. 72:
THE DECISION, liberamente ispirato a La linea di condotta di Bertolt Brecht. Ideazione e regia di Lorenzo Bazzocchi. Scene di Lorenzo Bazzocchi, Catia Gatelli, Eleonora Sedioli. Con Matteo Ramon Arevalos, Lorenzo Bazzocchi, Catia Gatelli, Giacomo Piermatti, Eleonora Sedioli. Prod. Masque teatro, FORLÌ - Mood indigo, BOLOGNA.
Michele Pascarella
---
Recensione di Maestro Eckhart di Alessandro Berti, p. 72:
Berti incontra Eckhart
MAESTRO ECKHART, drammaturgia, traduzione e regia di Alessandro Berti. Costumi di Nicoletta Di Gaetano. Con Alessandro Berti e Angela Caterina. Prod. Casavuota, BOLOGNA - I Teatri del Sacro, ROMA.
Michele Pascarella
---
Recensione di Suite Michelangelo di Città di Ebla, pp. 72-73:
Michelangelo racchiuso in un bozzolo-scultura
SUITE MICHELANGELO, di Claudio Angelini ed Elisa Gandini. Regia e luci di Claudio Angelici. Scene e costumi di Elisa Gandini. Musiche di Dimitri Šostakovič. Con Valentina Brevetti, Elisa Gandini, Riccardo Fioratti (baritono), Shizuka Salvemini (pianoforte). Prod. Città di Ebla, FORLÌ - Sagra Musicale Malatestiana, RIMINI.
Michele Pascarella
---
Recensione di Stava la madre di Angela Dematté, p. 77:
STAVA LA MADRE, di Angela Demattè. Regia di Sandro Mabellini. Con Angela Demattè, Giulia Zeetti. Musiche di Antonia Gozzi e Ambrogio Sparagna. Prod. Beat 72, ROMA.
Michele Pascarella
Exit - p. 99:
“La prima volta che mi sono sembrato un attore è stato quando ho incontrato Marco Martinelli e Gigio Dadina, perché quel giorno ho mentito”: Mandiaye N’Diaye raccontava così il suo incontro con il teatro, avvenuto nel 1989. Spiega Martinelli: “Dovevamo trovare tre giovani senegalesi: si trattava di un’emergenza, i compagni africani con i quali avevamo costruito il nostro primo spettacolo meticcio, Ruh. Romagna più Africa uguale, ci avevano lasciato dall’oggi al domani, pochi giorni dopo avremmo recitato all’ITC di Bologna, bisognava pensare in fretta a una sostituzione”. Così Mandiaye, in Italia da un anno e costretto a un lavoro da venditore ambulante nella riviera romagnola del quale era ovviamente scontento, si inventò un passato da teatrante. Da allora, per oltre due decenni, Mandiaye N’Diaye ha messo in vita più di ogni altro il “meticciato teatrale” delle Albe, protagonista di molti spettacoli “afro-romagnoli” tra i quali Lunga vita all’albero (1990), Nessuno può coprire l’ombra (1991), Vita e conversione di Cheikh Ibrahim Fall (2000) e Sogno di una notte di mezza estate (2002). In quel fertile periodo i lavori più memorabili sono forse I Polacchi (1998), spettacolo patafisico da Alfred Jarry in cui Mandiaye è un Padre Ubu grottesco che sproloquia in italiano, wolof e dialetto romagnolo e Griot Fulêr (1993), scritto assieme a Luigi Dadina e debuttato in Senegal, al centro del quale stanno due fiabe tradizionali, una senegalese e una romagnola, in cui si narra di un medesimo “maleficio dell’orma tagliata”. Negli anni si rafforza in lui la necessità di indagare le relazioni fra l’arte teatrale e la religione animista dei suoi antenati. Così, nel 2006, fonda a Diol Kadd, suo villaggio in Senegal, il Takku Ligey Théâtre, nome che in wolof significa “darsi da fare assieme”. Su questa feconda esperienza si vedano i bei volumi Takku Ligey: un cortile nella savana di Linda Pasina (Titivillus, 2011) e Passar la vita a Diol Kadd di Gianni Celati (Feltrinelli, 2011). Mandiaye N’Diaye è morto l’8 giugno 2014. Tre giorni dopo sarebbe dovuto arrivare in Italia per presentare il suo più recente spettacolo, Opera lamb. Per concludere questo breve ricordo, un piccolo passo indietro. Nel 1990 Mandiaye ha messo in scena, unico interprete, la fiaba senegalese Le due calebasse. L’attore terminava questo divertente racconto sussurrando con un largo sorriso: “Chi sente per primo questo profumo, va in Paradiso”. Poi inspirava forte, con le sue larghe narici africane. Buio.
Michele Pascarella
---
Biblioteca - p. 109:
Marco Martinelli e Ermanna Montanari
Michele Pascarella
Hystrio 2.2014:
Recensione di Dialogo degli schiavi di Claudia Castellucci | Socìetas Raffaello Sanzio, p. 66:
DIALOGO DEGLI SCHIAVI, ballata scritta e interpretata da Claudia Castellucci. Arrangiamenti musicali: Scott Gibbons. Prod. Socìetas Raffaello Sanzio, CESENA.
Michele Pascarella
Recensione di Tifone di Chiara Guidi | Socìetas Raffaello Sanzio, p. 68:
TIFONE, liberamente tratto da Joseph Conrad. Adattamento e regia di Chiara Guidi. Musiche originali di Fabrizio Ottaviucci. Con Chiara Guidi e Fabrizio Ottaviucci. Prod. Socìetas Raffaello Sanzio, CESENA.
Michele Pascarella





























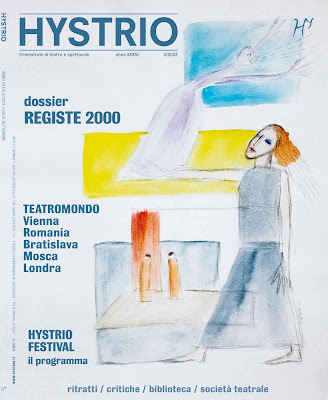



















































































































































































.jpg)


.jpeg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)












